Fotografie e video: Fondazione di Comunità Porta Palazzo
“Le fondazioni di comunità sono intermediari filantropici: soggetti in grado di promuovere la coesione sociale e lo sviluppo di un’area specifica. La vocazione verrà fuori gradualmente, a seconda di quello che il territorio specifico ritiene prioritario.”
Andrea Fabris, Compagnia di San Paolo (fonte: Napoli Monitor)
Nel cuore di Torino, tra le sponde della Dora Riparia e il mercato all’aperto più grande d’Europa, il quartiere Aurora-Porta Palazzo si distingue per la sua straordinaria complessità sociale, urbana e culturale. Con una densità abitativa che supera i 15.000 abitanti per chilometro quadrato e una presenza di cittadini stranieri superiore al 35%, Aurora rappresenta uno dei contesti più intensi e stratificati della città. Qui, in uno spazio segnato da trasformazioni urbanistiche, conflitti abitativi, fragilità sociali e tensioni interculturali, ha preso forma uno degli esperimenti più interessanti di rigenerazione urbana e innovazione civica in Italia: la Fondazione di Comunità Porta Palazzo.
Costituita nel novembre 2020 grazie all’impegno di associazioni come Fuori di Palazzo, Comitato Oltredora, Arcigay Torino “Ottavio May” e Associazione CoAbitare – cohousing Numero Zero, la Fondazione nasce dalla volontà di dare nuovo protagonismo al territorio, valorizzando il patrimonio immateriale fatto di relazioni, pluralità e capitale sociale diffuso. In un quartiere segnato dalla precarietà abitativa e dalla crescente distanza tra istituzioni e residenti, la Fondazione si propone come piattaforma civica per promuovere equità, coesione, responsabilità condivisa e accesso al diritto alla città (manifesto FCPP).
L’azione della Fondazione si fonda su una programmazione partecipata, in ascolto delle energie del territorio, e su una progettualità integrata che attraversa i temi dell’abitare sociale, della prossimità educativa e sanitaria, della rigenerazione degli spazi pubblici, della sostenibilità ambientale e della promozione culturale. Tra le iniziative più rilevanti spicca la nascita del primo Community Land Trust (CLT) italiano, promosso insieme all’ente Terreno Comune ETS, che ha portato a Torino un modello di proprietà collettiva del suolo urbano, ispirato a esperienze consolidate negli Stati Uniti e in Europa. Un modello capace di garantire accesso alla casa a famiglie escluse dal mercato e dalle graduatorie pubbliche, contrastare la speculazione e rafforzare il senso di appartenenza comunitaria.
La Fondazione Comunità Porta Palazzo si inserisce così nel solco delle più avanzate pratiche europee di filantropia civica, come sottolineato anche nel Bilancio di Missione 2023 di Fondazione Cariplo e in numerosi studi promossi dalla Compagnia di San Paolo. La sua esperienza si innesta su percorsi territoriali precedenti come The Gate – Porta Palazzo e dialoga oggi con altre realtà torinesi come le Portinerie di Comunità e le Case del Quartiere, in un ecosistema urbano che tenta di sperimentare nuovi strumenti di governance, prossimità e sostenibilità.
Questa intervista nasce per esplorare, attraverso la voce di Cecilia Guiglia, presidente della Fondazione, le sfide, le contraddizioni e le potenzialità di un nuovo modello di fondazione civica, che si propone come laboratorio di cittadinanza attiva, redistribuzione urbana e innovazione democratica. A partire dal CLT ma aprendosi anche agli altri progetti, l’intervista intende offrire una lettura critica e propositiva di ciò che significa, oggi, fare comunità in una città complessa.





Fondazione Comunità Porta Palazzo: modello e identità.
Nel panorama delle fondazioni di comunità italiane, la Fondazione Comunità Porta Palazzo rappresenta un esperimento originale e profondamente radicato nel territorio. Nata nel 2020 nel quartiere Aurora–Porta Palazzo, a Torino, la Fondazione si è costituita come risposta dal basso alla crescente disuguaglianza urbana, alle tensioni legate alla convivenza interculturale e alla frammentazione del tessuto sociale. Più che un semplice ente del Terzo Settore, la FCPP si propone come piattaforma civica ibrida, capace di attivare reti, produrre innovazione sociale e garantire un diritto alla città effettivo per tutti i residenti.
A distinguerla è l’intreccio tra governance partecipata, visione sistemica e radicamento territoriale: tre elementi che la rendono non solo un soggetto erogatore di risorse, ma un abilitatore di processi collettivi. Le sue progettualità – dall’abitare sociale alla prossimità educativa, dalla rigenerazione urbana alla sostenibilità ambientale – non sono interventi settoriali, ma tessere di una strategia integrata di coesione. In questo quadro si inserisce anche il primo Community Land Trust (CLT) operativo in Italia, promosso dalla Fondazione: un modello che sottrae la proprietà immobiliare alla speculazione, per restituirla all’uso collettivo e alla giustizia territoriale.
Questo primo capitolo intende mettere a fuoco la genesi, i tratti distintivi e il ruolo strategico della Fondazione nel contesto torinese e italiano, ponendo l’accento sulla sua capacità di sperimentare un nuovo paradigma di infrastruttura civica, fondato sulla prossimità, sulla cura e sulla corresponsabilità.
In questo orizzonte, anche il tema della grave marginalità adulta viene affrontato non come “area d’intervento” specialistica, ma come fenomeno relazionale e territoriale, che interpella l’intera comunità. L’esperienza del
Giardino Pellegrino, frequentato da persone senza dimora e da famiglie del quartiere, e i percorsi di cittadinanza attiva femminileche si sono attivati intorno a quello spazio, mostrano come la Fondazione abbia scelto di non gestire la marginalità con approcci caritatevoli o emergenziali, ma di costruire contesti inclusivi e regole condivise, in cui la convivenza si apprende giorno dopo giorno, attraverso la pratica.
La marginalità, in questa visione, non è un problema da isolare o delegare a professionisti del sociale, ma una frattura collettiva che può diventare terreno di trasformazione. È in questo senso che la Fondazione sceglie di non lavorare “per” le persone fragili, ma insieme a loro, attivando processi di riconoscimento reciproco, di giustizia urbana e di ridefinizione del bene comune.
Mario Flavio Benini. La gestione della grave marginalità adulta da parte del Terzo Settore – salvo alcune esperienze più evolute – resta spesso ancorata a risposte emergenziali e pratiche caritatevoli. È un modello che garantisce una certa tenuta dell’ordine sociale, ma difficilmente produce trasformazione. In particolare, il ruolo del volontariato tende a rimanere subordinato, incanalato in una “logica estrattiva”: attività ripetitive, di bassa complessità, non retribuite, funzionali al funzionamento quotidiano dell’organizzazione, ma scollegate da percorsi di formazione, consapevolezza o riconoscimento. In questo schema, la cittadinanza attiva rischia di essere svuotata, e il potenziale politico delle relazioni viene disperso. Come vi siete confrontati, nella vostra esperienza, con questi limiti e contraddizioni? Come avete cercato di generare spazi che non si limitino a gestire la marginalità, ma che favoriscano una trasformazione del ruolo delle persone e delle comunità?
Cecilia Guiglia. È un tema che ci ha interrogato fin da subito. Non tanto in astratto, quanto nella concretezza di ciò che osservavamo attorno a noi. Sapevamo dove si trovavano le persone senza dimora nel nostro quartiere. E questa consapevolezza è diventata quasi subito una dimensione di pratica. Penso, ad esempio, al Giardino Pellegrino, che abbiamo contribuito a riaprire dopo anni di chiusura: si trova proprio davanti al Sermig (Servizio Missionario Giovani), in un’area con bassa densità abitativa, ma dove gravitano molti soggetti fragili. Accanto al Sermig c’è anche il Cottolengo, la mensa per persone in difficoltà più grande della città. Era evidente che il giardino sarebbe diventato uno spazio frequentato anche da chi vive in strada.
E proprio per questo, la riapertura non è stata semplice. Una parte della popolazione si opponeva, temeva che il giardino diventasse una “nuova casa” per i senza dimora. Quella resistenza ci ha costretto ad affrontare subito, e in modo diretto, la questione. A farlo è stato un gruppo di cittadine, tutte donne e per lo più pensionate, che si sono rese disponibili a misurarsi con quella complessità. È interessante osservare che quel gruppo fosse interamente femminile: c’era una matrice di cura molto forte, ma anche una disponibilità sincera a mettersi in gioco.
Abbiamo coinvolto il Gruppo Abele per facilitare un percorso di confronto e apprendimento. Abbiamo incontrato volontari, responsabili di strutture, referenti del Sermig, per capire come erano organizzati gli interventi. Ma presto ci siamo rese conto che la nostra posizione – quella di cittadine attive – non trovava una collocazione chiara. L’idea che l’unico contributo possibile fosse offrire conforto o assistenza rientrava in una logica caritatevole, cristiana, più che in una visione politica. E per chi si considerava attivista, questo rappresentava un limite.
Abbiamo deciso quindi di non strutturare azioni specifiche “per” le persone senza dimora, ma di lavorare sul contesto. L’obiettivo era semplice e al tempo stesso radicale: evitare che venissero espulsi da uno spazio pubblico, ma anche evitare che lo occupassero in modo esclusivo. Volevamo che potessero condividere quello spazio con altri, in una logica di convivenza.
Il momento storico – eravamo nel pieno del post-Covid – rendeva ancora più urgente restituire alla cittadinanza luoghi aperti e accessibili. Ma intanto la mensa del Cottolengo, per ragioni sanitarie, aveva smesso di servire i pasti al chiuso: i pasti venivano distribuiti in contenitori di plastica, in sacchetti di plastica, e consumati nel giardino. I rifiuti si accumulavano.
Quel gruppo di donne ha trovato una risposta semplice ma potente: ogni giorno, all’ora di pranzo, si presentavano al giardino con un thermos di caffè. E attraverso questo piccolo gesto hanno avviato una relazione. Offrivano un caffè e, con garbo, chiedevano che i rifiuti venissero raccolti. È stata coinvolta l’AMIAT per predisporre una raccolta adeguata. E per un periodo, nel giardino, non si è più vista plastica a terra. Non è stato un progetto, è stata una pratica quotidiana di cittadinanza. Un trattarsi da pari, con regole condivise.
Parallelamente, due donne del gruppo – più strutturate, più determinate – hanno scelto di affiancarsi a chi si occupava di marginalità in modo più sistematico. Insieme all’associazione Mosaico, che si occupa prevalentemente di rifugiati ma lavora anche con migranti in condizione di grave esclusione, hanno dato vita a una piccola unità di strada. All’inizio non pensavamo sarebbe stato possibile: la realtà che li ha sostenuti è vicina a Compagnia delle Opere, quindi con visioni molto lontane dalle nostre. Ma si sono dimostrati disponibili e competenti. Oggi quell’unità esiste, ha ampliato le sue attività, ha trovato appoggio anche nella parrocchia vicina al Sermig e sta dando vita a una seconda unità nel quartiere Barriera di Milano.
Non è stato un processo pianificato, ma un movimento spontaneo, fatto di alleanze improbabili, incontri imprevisti, fiducia costruita giorno dopo giorno. Quando abbiamo provato a entrare nel coordinamento cittadino delle realtà che si occupano di senza dimora, ci siamo sentiti fuori posto. C’era una sensazione sgradevole: come se tutto si riducesse a “tenere le persone tranquille”, a garantire una gestione ordinata della sopravvivenza. A noi sembrava che mancasse proprio la dimensione politica, il desiderio di trasformare.
E allora abbiamo scelto di partire dal basso, da quello che si poteva fare nel nostro spazio. E da lì, lentamente, abbiamo iniziato ad agganciare pezzi di città, di reti, di saperi. Un processo lento, ma reale.
Mario Flavio Benini. Occuparsi di grave marginalità adulta significa intervenire là dove tutto è stato perso: non solo il lavoro o la casa, ma anche i legami familiari, le amicizie, i riferimenti sociali e simbolici. Le ricerche più attente sottolineano come non sia quasi mai solo una questione economica: la povertà materiale può essere l’innesco, ma ciò che davvero sprofonda è la rete delle relazioni e della fiducia. Con il tempo si consolidano pratiche, ritmi e abitudini di sopravvivenza che rendono difficile anche solo immaginare un ritorno alla “normalità”. Ecco perché ogni percorso di uscita richiede non tanto l’erogazione di servizi standardizzati, quanto la costruzione di relazioni di senso, capaci di tenere insieme fragilità, biografie complesse, linguaggi misti di verità e finzione, senza ridurre l’altro a un codice fiscale. In questo quadro, quale ruolo può giocare – secondo voi – la cittadinanza attiva, quella che non delega, ma che sceglie di esserci, di condividere, di accompagnare senza giudicare?
Cecilia Guiglia. Oltre a essere cittadini attivi, siamo persone che portano con sé competenze professionali, biografie, reti. È una delle caratteristiche distintive della nostra Fondazione: attivare non solo disponibilità, ma intelligenze esperte, saperi maturati nei mestieri della vita e relazioni costruite nel tempo. Questo approccio ci consente di osservare le fragilità urbane da più punti di vista e di costruire risposte articolate. Io, ad esempio, mi occupo da anni di abitare sociale, con un’attenzione specifica ai percorsi migratori. Negli ultimi dieci anni ho lavorato su modelli di innovazione abitativa che incrociano fragilità e mobilità, e questa traiettoria incide anche nel modo in cui la Fondazione si relaziona al tema della marginalità estrema.
Torino ha iniziato, anche grazie al PNRR, a rafforzare alcuni strumenti di bassa soglia, come le Stazioni di Posta. Ma la nostra convinzione, maturata sul campo, è che la risposta più efficace per la marginalità grave sia rappresentata oggi dal modello Housing First. Perché partire dalla casa non è solo un atto concreto: è un gesto politico. Non si può chiedere a chi è in strada di dimostrare di essere “pronto” prima di accedere a un’abitazione. Abitare non è un premio per chi si redime, è la base per riattivare una biografia. Solo una casa permette di interrompere il ciclo della cronicizzazione – quel processo in cui il disagio si somma all’isolamento, e l’isolamento alla sfiducia, fino a rendere quasi impossibile la ripartenza.
Housing First funziona anche perché costruisce consenso trasversale. In fondo, “togliere persone dalla strada” può essere un obiettivo condiviso anche da posizioni politiche molto diverse. Ma quello che ci interessa non è l’ordine pubblico: è la possibilità di restituire alle persone uno spazio in cui ricostruire relazioni, autonomia, desideri. A Torino abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con esperienze solide, come quelle della Cooperativa Tenda con Progetto Tenda, che non a caso ha espresso anche la presidenza italiana della rete Housing First. Il loro lavoro è un riferimento per tutti: per la serietà, per la cura, per la capacità di costruire percorsi sostenibili. Abbiamo attinto alle loro competenze per formulare proposte anche nei confronti dell’amministrazione: non per sostituirci, ma per sapere cosa chiedere, in modo sensato.
Il nostro metodo è questo: partire dall’osservazione concreta dei fenomeni sul territorio e poi guardare altrove, confrontarsi con modelli nazionali e internazionali, posizionarsi. Partecipiamo, anche se informalmente, a reti come il Forum Disuguaglianze e Diversità. Andiamo ai loro incontri, alle scuole, ai webinar. Non per aderire simbolicamente, ma per apprendere, per selezionare, per raffinare lo sguardo.
Alla base di tutto, c’è una scelta: quella della prossimità. Non è un obbligo, è un orientamento. Abbiamo deciso di non lavorare per temi – non siamo “quelli della povertà” o “quelli della disabilità” – ma per territorio. Perché è nel territorio che le persone vivono intere, con le loro contraddizioni, i loro attraversamenti. E solo il lavoro territoriale permette di costruire una visione d’insieme. Permette anche di superare quella frustrazione diffusa che spesso accompagna chi opera nel sociale: perché quando vedi che una comunità come Aurora Comunità di Cura riesce, in pochi anni, a far accedere ai servizi circa 600 persone – in un territorio complesso, con 39.000 residenti ufficiali ma una presenza reale molto più alta – capisci che stai costruendo fiducia. Non risolvi, ma ti prendi cura. E questo, per noi, è già un atto politico.
Mario Flavio Benini. Partiamo dall’inizio: qual è stato il contesto da cui è nata la Fondazione Comunità Porta Palazzo e quali soggetti hanno dato impulso a questo percorso?
Cecilia Guiglia. La nascita della Fondazione è legata a una battaglia molto concreta, che ci ha messi in conflitto con l’amministrazione pubblica. Tutto è cominciato quando si è deciso di spostare il Mercato del Libero Scambio del Balon dal quartiere: un mercato storico, informale, dove per generazioni le persone hanno venduto oggetti di seconda mano, abiti dismessi, piccoli beni di uso quotidiano. Un mercato popolare nel vero senso del termine, che negli anni aveva assunto anche un valore sociale ed economico rilevante in prevalenza per le persone migranti, ma anche per le persone non migranti che ne traevano sostentamento e per chi, con pochi mezzi, riusciva ad acquistare ciò che serviva per mettere in piedi una casa o crescere dei bambini.
Questa realtà, radicata nella cultura materiale del quartiere e perfettamente in sintonia con alcune abitudini nordafricane, si è scontrata con l’idea dell’amministrazione di estendere l’attrattività turistica dal centro città fino alla Dora. In mezzo, però, c’era proprio il mercato del sabato, e il suo spostamento è diventato terreno di conflitto. A quel punto, alcune realtà del territorio – molte delle quali già attive da anni – si sono ritrovate a condividere un’opposizione non solo simbolica, ma profondamente politica, al ridisegno “gentrificante” dello spazio urbano.
Per quanto la battaglia sia stata persa – il mercato è stato ridotto ai soli operatori iscritti al registro del commercio, mentre gli altri si sono dovuti spostare altrove – è stato in quel momento che è maturata una consapevolezza: non avevamo voce. Facevamo azioni, promuovevamo relazioni, ma non avevamo parola. Da lì è nata l’idea di costruire uno strumento capace non solo di rivendicare, ma di proporre: uno strumento per immaginare, progettare, dare forma a una visione di città diversa.
Abbiamo scelto il modello della Fondazione di Comunità per due motivi. Il primo è legato alla governance: a differenza delle associazioni, le fondazioni possono essere disegnate liberamente, senza dover rispondere a un modello prestabilito. Questo ci ha permesso di costruire una struttura ampia, paritaria, fondata sull’assenso e sulla co-costruzione, sia della visione che delle pratiche. Il secondo motivo è legato alla natura giuridica: le fondazioni possono raccogliere e ridistribuire risorse senza generare plusvalenze tassabili, e quindi senza entrare in conflitto con il sistema imprenditoriale. Non possiamo emettere fatture o vendere servizi, ma possiamo creare fondi mutualistici, destinare risorse, sostenere progetti. E questo ci sembrava uno strumento utile, funzionale.
Ci abbiamo messo un anno e mezzo per scrivere lo statuto, lavorando con 35 persone provenienti da realtà molto diverse, riunite ogni quindici giorni con il metodo dell’assenso. Un processo lungo, ma prezioso: ha prodotto un patrimonio collettivo di confronto e decisione, che è diventato la base della nostra azione.
Nel frattempo, l’emergenza Covid ha portato alla luce molte fragilità e ha spinto anche realtà strutturate a rimettere al centro il territorio e le sue reti di prossimità. In Aurora convivono piccole associazioni informali e soggetti di rilievo nazionale e internazionale – come il Cottolengo, il Sermig o l’Opera Barolo – che, pur presenti nel quartiere da tempo, fino a quel momento avevano avuto traiettorie autonome e raramente si erano confrontati tra loro su una visione condivisa dello spazio urbano. La crisi pandemica ha innescato un cambio di prospettiva, generando nuove connessioni e forme di cooperazione. È nato così un coordinamento, promosso da una delle associazioni del quartiere con il supporto di ActionAid, che ha messo insieme 48 soggetti. Questo coordinamento ha gestito risorse, ma soprattutto ha promosso un’azione politica condivisa: ha chiesto e ottenuto, ad esempio, che anche le persone senza permesso di soggiorno potessero accedere a Torino Plurale e, successivamente, a Torino Solidale.
In questo contesto, la Fondazione non si è posta come un contenitore da riempire, ma come uno strumento operativo al servizio del territorio, una piattaforma capace di sostenere chi, nel concreto, si assume responsabilità collettive. Abbiamo deciso fin dall’inizio di non costruire una struttura inclusiva “per principio”, ma di fondare l’appartenenza sulla pratica condivisa: non si entra a far parte della Fondazione per adesione formale, ma dopo aver lavorato insieme, fianco a fianco, su progetti e attività che richiedono cooperazione reale, impegno, cura. Perché per noi la qualità delle relazioni si misura nel fare, non nelle dichiarazioni d’intenti.
In questa logica, chi condivide una visione – che non è “la visione giusta”, ma è la nostra visione, situata, costruita nel tempo, coerente con un’idea di giustizia territoriale e di mutualismo – trova nella Fondazione strumenti concreti: la capacità di attivare risorse, progettare in forma collettiva, sostenere sperimentazioni.
Uno dei primi risultati tangibili di questo approccio è stato la costituzione di un fondo mutualistico comunitario, nato proprio dalla collaborazione con il coordinamento delle 48 realtà attive nel quartiere durante il Covid. Questo fondo non si è limitato alla distribuzione alimentare: ha permesso di fornire beni essenziali come prodotti per l’igiene, pannolini, detergenti, rispondendo a bisogni reali in modo rapido, adattivo, con una capacità logistica e relazionale che ha fatto emergere la forza del territorio. La risposta efficace e tempestiva delle realtà coinvolte ha rafforzato la fiducia reciproca, anche con l’amministrazione cittadina, che ha riconosciuto il valore di quanto stava accadendo in Aurora.
Questa esperienza ha confermato la nostra intuizione iniziale: per trasformare un territorio non basta opporsi o denunciare, serve portare strumenti e visione. La Fondazione funziona – e vuole funzionare – come una leva per chi desidera costruire, non come uno spazio neutro dove tutto e il contrario di tutto possono convivere. Non ci interessa includere a tutti i costi, ma essere utili a chi sceglie di condividere un percorso comune, fatto di prossimità, responsabilità e progettualità condivisa.
Mario Flavio Benini. Uno degli elementi distintivi della Fondazione Comunità Porta Palazzo è la sua governance partecipata. Come si è costruito questo modello? Quali strumenti e pratiche avete messo in campo per rendere il processo realmente condiviso?
Cecilia Guiglia. Il tema della partecipazione, per noi, è stato sin dall’inizio un elemento da curare in profondità, e lo facciamo attraverso due livelli distinti ma intrecciati. Da un lato c’è la partecipazione operativa, concreta, che avviene nei gruppi di lavoro: sono questi i luoghi dove si sperimentano azioni, si curano processi, si definiscono priorità. Non tutte le persone che partecipano a questi gruppi fanno parte formalmente della Fondazione, e va benissimo così: chi prende responsabilità su un’azione può farlo anche da esterno, purché lo faccia con continuità. La Fondazione garantisce supporto, strumenti, copertura assicurativa – purtroppo dobbiamo usare ancora il termine “volontari”, non “cittadini attivi” per ragioni formali – ma non chiede adesione identitaria.
Ciascun gruppo di lavoro ha un proprio obiettivo e un certo grado di autonomia. Prendiamo ad esempio il gruppo sullo spazio pubblico, che al suo interno ha tre filoni: la cura del Giardino Pellegrino, il progetto di pedonalizzazione del Borgo – che è stato un esperimento difficile, anche politicamente – e il progetto Intreccio, legato al bando ImpatTo sul Giardino Madre Teresa di Calcutta. Ogni gruppo si riunisce, valuta le esperienze in corso, elabora proposte e – se necessario – formula richieste strategiche. Recentemente, ad esempio, hanno proposto di coinvolgere Elena Granata nel Consiglio di Indirizzo, perché sentono il bisogno di confrontarsi con una visione urbanistica più ampia, capace di interrogarsi sull’uso dei luoghi in chiave transgenerazionale, transnazionale, transgenere. Questo bisogno nasce dalla pratica: si fa, si osserva, e poi si riflette insieme.
Il secondo livello riguarda la partecipazione interna, più legata al funzionamento della Fondazione stessa. Tutti i gruppi di lavoro si interfacciano con il Comitato Esecutivo e con lo staff che garantisce operatività tre giorni a settimana, offrendo coordinamento e strumenti. Ma il cuore dell’elaborazione collettiva è l’Assemblea territoriale, che si riunisce mediamente quattro volte all’anno, di cui una in forma intensiva su due giornate. È lì che avviene il confronto tra i gruppi, il riconoscimento reciproco, la co-costruzione delle scelte strategiche e delle priorità. Il nostro piano strategico è nato proprio così: dai gruppi di lavoro e dall’Assemblea, non da un direttivo chiuso.
Oggi però ci troviamo davanti a nuove sfide, perché sono entrate in gioco realtà molto diverse tra loro, con storie, linguaggi e culture differenti. L’Associazione piemontese dei Filippini, un’associazione di secondo livello della comunità cinese, un gruppo legato a una moschea, un centro italo-arabo con un ruolo nel Comitato Interfedi, e altre espressioni culturali: tutte portatrici di visioni e pratiche che ci interrogano su come ridefinire la partecipazione. Se finora eravamo un gruppo di attivisti che si era scelto, oggi dobbiamo costruire spazi di confronto che siano accessibili anche a chi parte da mondi altri, con forme e motivazioni differenti. È un passaggio delicato ma necessario.
Per accompagnare questo percorso, abbiamo avviato una riflessione collettiva chiedendo alla Fondazione per l’Innovazione Urbana di Bologna di aiutarci a costruirlo. Insieme abbiamo realizzato cinque incontri in cui ci hanno raccontato alcune esperienze maturate nel contesto bolognese, in particolare quelle che hanno coinvolto diverse associazioni impegnate nella costruzione dei quartieri. Ci sembravano percorsi particolarmente avanzati nel modo in cui mettevano in dialogo competenze eterogenee e motivazioni plurali, a partire dalla volontà di tenere insieme visione, pratica e azione. In alcuni momenti abbiamo trovato forti sintonie; in altri invece ci siamo sentiti un po’ spaesati, con reazioni del tipo: “Ma di cosa stanno parlando?”. Anche questo è stato per noi un elemento importante di confronto e apprendimento. Ed è giusto così: il confronto vero non è mai lineare. Ma il punto è proprio questo: stiamo imparando a ridefinire le forme della partecipazione, senza trasformarla in un rito, ma lasciandole la possibilità di evolvere con le persone che la attraversano.


I progetti della Fondazione: strumenti per una città giusta.
L’identità della Fondazione Comunità Porta Palazzo si costruisce nella pratica quotidiana di progetti concreti, articolati su più livelli ma uniti da una visione condivisa: abitare un quartiere significa viverlo in modo collettivo, prendersene cura, renderlo accessibile, inclusivo, sostenibile. Non si tratta solo di intervenire dove emergono bisogni urgenti, ma di immaginare risposte strutturali, capaci di generare legami, capacitazione, fiducia.
Sul fronte abitativo, la Fondazione ha scelto di agire su due piani distinti ma complementari. Da un lato, con il progetto La comunità è di casa, lavora per prevenire gli sfratti nei quartieri di Aurora e Mirafiori, offrendo consulenza legale, mediazione sociale, educazione finanziaria e un accompagnamento personalizzato alle famiglie in difficoltà. Il progetto si rivolge in particolare a nuclei monoreddito o con fragilità croniche, alcuni dei quali si trovano al limite della perdita della casa e della condizione di senza dimora. In questo senso, la Fondazione si pone come attore di prossimità in grado di intercettare le marginalità prima che si trasformino in esclusione abitativa estrema.
Dall’altro lato, con la nascita del primo Community Land Trust (CLT) italiano, ha promosso un modello innovativo di proprietà collettiva del suolo urbano, sottraendo gli immobili alla speculazione e rendendo l’abitare accessibile a famiglie escluse sia dal mercato sia dalle graduatorie pubbliche. Il CLT offre una soluzione abitativa stabile e antispeculativa anche a persone prive di garanzie formali o senza piena residenza anagrafica, una condizione che spesso ostacola l’accesso all’edilizia sociale tradizionale e può avvicinare a forme di grave precarietà abitativa. Le abitazioni, di piccola dimensione e flessibili, sono concepite come tappe abilitanti di un percorso di autonomia, non come soluzioni definitive. La separazione tra proprietà del suolo (in capo alla Fondazione) e quella dell’immobile garantisce l’accessibilità nel tempo e la possibilità di creare capitale di capacitazione per le famiglie, ispirandosi anche al modello della Fondazione Me.S.S.In.A.
Accanto all’abitare, la Fondazione lavora per costruire reti di prossimità e mutualismo. Il progetto Aurora Comunità di Cura ha seguito oltre 260 nuclei familiari, in particolare migranti, offrendo orientamento ai servizi, supporto educativo e relazionale, con una forte componente interculturale e intergenerazionale. Il Fondo Comune Mutualistico Sostieni Aurora a rappresentato una risposta rapida e relazionale a situazioni di bisogno improvviso, sostenendo famiglie che non riescono ad accedere alle reti istituzionali. Il fondo nasce da un percorso di progettazione partecipata con le associazioni del territorio, ed è pensato non solo come strumento di sostegno economico, ma come leva per rafforzare relazioni, responsabilità condivisa e fiducia reciproca. In questo sistema di protezione e cura, la Fondazione ha progressivamente allargato le maglie dell’intervento, includendo soggetti in condizioni di vulnerabilità abitativa e sociale estreme.
Il progetto Percorsi Divergenti affronta la disabilità con uno sguardo di comunità: lavorando con famiglie con figli nello spettro autistico, promuove accesso ai servizi, auto-mutuo aiuto, sensibilizzazione scolastica e formazione. Anche qui, l’approccio relazionale e territoriale aiuta a prevenire l’isolamento e la cronicizzazione della marginalità.
Ma la coesione si gioca anche negli spazi pubblici, dove la rigenerazione partecipata diventa leva di cittadinanza attiva e benessere collettivo. Con il progetto La comunità del Pellegrino, il Giardino Pellegrino è stato rigenerato come orto urbano, spazio di gioco e di eventi pubblici. Con Via Mameli strada scolastica, è stata sperimentata una chiusura temporanea al traffico, trasformando la mobilità quotidiana dei bambini in occasione di partecipazione e trasformazione dello spazio urbano.
Infine, la Fondazione guarda al futuro attraverso una doppia traiettoria: ambientale e sociale. Il progetto delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali promuove la produzione e la condivisione di energia rinnovabile, legando sostenibilità ecologica e contrasto alla povertà energetica. Il più recente progetto L’Intreccio attiva presidi comunitari, laboratori e percorsi di prossimità a Corso Giulio Cesare 34, in stretta sinergia con l’abitare del CLT e con le reti sociali più fragili del territorio, contribuendo a prevenire le derive della marginalità estrema.
Mario Flavio Benini. Aurora–Porta Palazzo è un territorio complesso, segnato da una forte presenza multiculturale, da fragilità sociali e da una lunga storia di marginalità ma anche di attivismo civico. In contesti come questi, costruire fiducia e capitale sociale non è solo una condizione necessaria per far funzionare i servizi, ma diventa il presupposto per immaginare forme di convivenza e sviluppo condivise. Robert Putnam ha mostrato come la qualità della vita civica sia strettamente legata alla densità delle reti relazionali e alla fiducia reciproca: mi sembra che il vostro lavoro si muova proprio in questo spazio intermedio, tra bisogno e visione, tra azione concreta e costruzione di orizzonti comuni.
Non vi limitate a raccogliere bisogni – che pure è già un compito complesso, perché richiede di indirizzarli verso risposte praticabili – ma cercate di intercettare anche aspirazioni, desideri, ambizioni. E questo è molto più difficile, perché spesso le domande non sono chiare, o non sono nemmeno formulate. Richiede un lavoro lungo di ascolto, di interpretazione condivisa, di chiarificazione reciproca. Mi interessa capire: in che modo, a partire da questo ecosistema comunitario che avete contribuito a generare, riuscite a costruire una visione strategica condivisa? Quali sono le pratiche, le condizioni e gli strumenti che rendono possibile questo passaggio dall’urgenza alla trasformazione collettiva?
Cecilia Guiglia. Un pezzo fondamentale è stato il coordinamento tra le realtà del quartiere. Anche in vista dell’arrivo di alcuni bandi destinati ai territori fragili, abbiamo provato a costruire una visione condivisa tra le 48 realtà attive nell’area. Non è stato semplice. Alcuni gruppi più antagonisti, soprattutto nel periodo del Covid, si sono sfilati dichiarando apertamente che non volevano mediare con soggetti con cui non condividevano alcun terreno comune. Allo stesso modo, alcune realtà molto strutturate e autoreferenziali – come il Sermig o il Cottolengo – hanno ritenuto di non aver bisogno di partecipare a un confronto collettivo: hanno una propria traiettoria autonoma, non interessata a discutere o negoziare con altri la propria visione. È rimasto però un gruppo che ha scelto di restare, e che ha deciso di lavorare là dove si poteva davvero aggiungere valore, integrando invece di duplicare.
Il primo passaggio è stato il lavoro sullo spazio pubblico, dove abbiamo coinvolto anche soggetti esterni come il Politecnico di Torino, attraverso Aurora Lab. Ma non è stato semplice nemmeno lì: le modalità di vivere e rappresentare lo spazio sono profondamente diverse tra culture, e abbiamo faticato a trovare una narrazione comune. Tuttavia, su alcuni princìpi siamo riusciti ad allinearci: ad esempio sull’idea che nessuno debba essere espulso dagli spazi comuni, che la convivenza inclusiva è un obiettivo da perseguire. E da lì ognuno ha iniziato a progettare nel proprio ambito, ma convergendo verso obiettivi comuni.
Un secondo passaggio, più profondo, è stato entrare nel merito: fidarci di più, condividere strumenti, costruire processi. La Fondazione ha cercato ogni volta di farsi promotrice di percorsi concreti, portando risorse economiche, strumenti di accompagnamento e competenze professionali. Un esempio importante è il Fondo Sostieni Aurora, nato per offrire sostegno economico a persone in condizioni di fragilità, ma attraverso un meccanismo che rafforza le relazioni e il tessuto comunitario: non sono le persone a chiedere direttamente al fondo, ma si attiva una relazione tramite le associazioni, che diventano garanti del legame, della conoscenza e della responsabilità condivisa.
Per costruire questo strumento abbiamo coinvolto una professionista di microfinanza di comunità, che ha accompagnato un gruppo di associazioni in un percorso di formazione e co-progettazione. I primi incontri sono serviti a esplorare insieme che cosa significhi fare microfinanza dal basso, quali sono le possibilità di evoluzione e le forme ibride che si possono costruire. Poi siamo passati alla scrittura condivisa del regolamento del fondo, discutendo in profondità il senso di parole come reciprocità, restituzione, circolarità delle risorse. Abbiamo affrontato anche le differenze culturali e religiose: ad esempio, il divieto di interessi nei prestiti per le comunità musulmane ci ha portato a riformulare i meccanismi di rotazione e a comprendere come funziona il risparmio collettivo in diversi contesti culturali. In quelle discussioni abbiamo visto nascere una visione collettiva plurale, intergenerazionale, interculturale.
Ci siamo detti: questo è il metodo. Prendere qualcosa di concreto, tangibile, necessario – come un fondo di mutuo aiuto – e a partire da lì costruire riflessione, consapevolezza, visione. È una metodologia che vorremmo replicare anche su altri ambiti, ad esempio sulla gestione condivisa dei giardini pubblici, con l’idea di costruire insieme un Patto di Comunità che disciplini la cura, l’uso, la responsabilità. La riflessione, per noi, parte sempre dalla pratica. Solo ciò che si fa, insieme, può diventare davvero oggetto di pensiero collettivo e strategia trasformativa.
Mario Flavio Benini. Un’altra sfida chiave è quella della comunicazione. Spesso è l’anello debole nei progetti sociali: strumenti improvvisati, risorse insufficienti, una sottovalutazione del suo potenziale trasformativo. Eppure, è proprio la comunicazione che permette alle pratiche di circolare, di generare senso, di allargare la partecipazione. Come lavorate su questo fronte?
Cecilia Guiglia. La comunicazione per noi è fondamentale. Ma anche molto faticosa. Lo è sia dal punto di vista operativo – abbiamo solo una persona part time su tre dello staff che se ne occupa – sia da quello politico: perché ogni scelta comunicativa tocca temi identitari, culturali, sensibili. Penso, ad esempio, alla grafica del sito della Fondazione: abbiamo lavorato con un’illustratrice e ci siamo interrogati se mettere volti colorati, trasparenti, neutri… Ogni dettaglio portava con sé una domanda sul linguaggio, sull’inclusività, sull’estetica politica. È un tema delicato, che richiederebbe una cura continua.
Ma la spinta alla comunicazione nasce anche da dentro. Noi non siamo un’impresa, siamo una comunità attiva. Ogni persona che si avvicina alla Fondazione porta anche il desiderio di sapere, di capire, di condividere. E la comunicazione è uno degli strumenti per rendere questo possibile. In questo senso abbiamo fatto vari esperimenti: newsletter che non funzionano, incontri che faticano a ingaggiare, tentativi e aggiustamenti continui.La nostra “misura del successo” non è quanti soldi raccogliamo, ma quante persone si avvicinano. Quante nuove reti, nuove relazioni riusciamo a costruire. Ecco perché la comunicazione è centrale. È l’ossatura che tiene insieme le pratiche. Quando abbiamo raccolto 480.000 euro per il Community Land Trust, in soli due mesi e mezzo, l’abbiamo fatto con una campagna costruita nelle sere e nei weekend, senza poterla nemmeno promuovere pubblicamente. È stato un lavoro intenso, ma anche appassionante, e ha funzionato perché tutte le persone coinvolte sapevano perché lo stavano facendo. L’obiettivo non era solo economico, ma di significato.
La comunicazione, per noi, non è una vetrina. È un gesto politico, un modo per costruire cittadinanza attiva, per coinvolgere alla pari. E per farlo, serve tempo, visione, capacità di ascolto. Ci andiamo per approssimazioni, ma con la consapevolezza che è un passaggio cruciale per non chiuderci, per restare permeabili, aperti, in relazione.
Mario Flavio Benini. La vostra azione si muove su più fronti – casa, salute, educazione, spazio pubblico, ambiente – intrecciando una trama articolata di interventi che rispondono non solo ai bisogni, ma anche alle aspirazioni del quartiere. In un contesto come Aurora–Porta Palazzo, segnato da dinamiche complesse e contraddittorie (povertà, arrivi migratori, processi di gentrificazione), come si costruisce nel tempo una visione strategica che tenga insieme queste tensioni, e trasformi un ecosistema comunitario in un dispositivo capace di generare impatto e non solo servizi?
Cecilia Guiglia. La nostra visione strategica parte da alcune domande di lettura del contesto: Aurora e Porta Palazzo sono quartieri attraversati da un processo di gentrificazione che è ormai sotto gli occhi di tutti. Ma per agire, non bastava denunciare. Serviva capire in profondità le dinamiche in atto: chi arriva, chi resta, chi se ne va. Quali sono le caratteristiche del tessuto urbano, sociale, abitativo. Quali le vulnerabilità, ma anche le risorse.
Aurora è da sempre il quartiere del primo approdo: prima dalle Valli di Lanzo, dal Veneto, poi dal Sud Italia, oggi dalle diaspore globali. Un territorio di transizione, continuamente riscritto da chi arriva. Le tipologie abitative stesse lo raccontano: case minute, spesso senza servizi igienici interni, nate per generare reddito – e oggi in parte rimaste invendute, invivibili o trasformate in strumenti di speculazione. Una parte consistente del patrimonio immobiliare è finita nelle mani di soggetti che lucrano sull’emergenza abitativa, generando forme di caporalato urbano, subaffitti, sovraffollamenti, sfruttamento.
Abbiamo quindi riconosciuto che l’abitare era il nodo chiave. Le persone arrivano, ma non restano. Perché qui non si vive, si sopravvive. Le scuole sono in trincea, con un turn over costante di studenti che spesso non parlano italiano. Le famiglie, appena possono, cercano di trasferirsi altrove. Eppure, questo continuo movimento ha un costo sociale enorme: per chi arriva e per chi già abita il quartiere. Allora la domanda è diventata: come trattenere, come costruire desiderio di permanenza?
Abbiamo lavorato su tre fronti. Il primo è la prevenzione dello sfratto: sostenere chi è già in casa, anche se in condizioni precarie, per evitare che venga espulso. Il secondo è l’avvio di una nuova offerta abitativa accessibile, fondata su modelli cooperativi e comunitari. Il terzo – più strutturale – è stato lo studio e l’adattamento del modello del Community Land Trust.
Abbiamo guardato a molte esperienze europee. In particolare, il Mietshäuser Syndikat tedesco ci ha affascinati per la sua capacità di sottrarre gli immobili alla rendita immobiliare, ma è un modello pensato per contesti in cui esistono già collettivi strutturati, con più unità co-abitative. Non era replicabile qui. Così abbiamo scelto di costruire un Community Land Trust torinese, mantenendo separata la proprietà del suolo da quella dell’immobile e garantendo la non speculabilità degli alloggi. Il suolo resta della Fondazione, gli appartamenti possono essere venduti ma non generano plusvalenze private: restano in un circuito di accessibilità controllata.
Inizialmente la città non ci ha sostenuto: eravamo una realtà giovane, fuori dai circuiti. Eppure ci siamo detti: lo facciamo noi, con le nostre forze. Abbiamo raccolto capitale sociale – non finanziario – da chi ha creduto nel progetto, con contributi che vanno dai 1.000 ai 30.000 euro. Ma ora quel capitale va restituito, va trasformato in case. Per questo abbiamo scelto la vendita controllata.
Il capitale di capacitazione, ispirato alla teoria di Amartya Sen e all’esperienza della Fondazione di Me.S.S.In.A. (ad esempio con il progetto sul Fondo Saccà), ci ha fornito una cornice teorica preziosa. Perché l’obiettivo non è solo dare un tetto, ma aumentare la libertà e la progettualità delle famiglie. Una quota di ciò che le persone versano non è un affitto che si perde, ma diventa un risparmio: un capitale che potranno reinvestire, in un’altra casa, in un’attività, in un progetto di vita trasformativa. Il punto è che la casa non sia una gabbia, ma una tappa.
Per questo costruiamo case piccole, accessibili, flessibili. Chi ha bisogno di più spazio, in un secondo momento, può cambiare, può uscire. L’importante è che questa prima esperienza permetta alle famiglie di diventare bancabili, di accedere a un mutuo, di costruirsi una storia finanziaria. E sappiamo che ci saranno difficoltà: per questo stiamo lavorando alla costruzione di un fondo mutualistico, che possa coprire le rate nei momenti di crisi, evitando espulsioni.
Il nostro è un modello evolutivo, che si costruisce passo passo, con grande fatica. Ma parte da una convinzione: che l’abitare sia il primo diritto negato e che solo trasformando il modo in cui si abita possiamo trasformare anche la cittadinanza. Siamo partiti dall’abitare, ma stiamo costruendo un ecosistema di possibilità.
Mario Flavio Benini In questi anni, anche in Italia, si sono sviluppate esperienze che cercano di affrontare la fragilità non solo in termini di assistenza, ma come leva per generare relazioni, consapevolezza e cambiamento. Penso, ad esempio, al progetto dell’Albergo Etico, che ha saputo valorizzare il lavoro come strumento di autonomia per ragazzi e ragazze con disabilità, promuovendo un nuovo sguardo sul tema dell’inclusione. Anche nel vostro progetto “Percorsi Divergenti” emerge un’impostazione simile: la disabilità non viene trattata come un problema da risolvere, ma come un’occasione per costruire prossimità, formare adulti e rafforzare comunità. Come è maturata questa scelta? E che cosa significa, per voi, fare welfare di comunità a partire da condizioni complesse, dove le fragilità si intrecciano e si sommano?
Cecilia Guiglia. Lavorando all’interno del gruppo Aurora Comunità di Cura ci siamo trovati a fare i conti con situazioni in cui più livelli di fragilità si sovrappongono: persone o famiglie che, pur non essendo portatrici di disagio sociale conclamato, a un certo punto non riescono più a reggere. Basta poco: essere stranieri, non conoscere la lingua, vivere in isolamento, crescere un figlio con disabilità senza avere strumenti adeguati. Ed è in questi intrecci che si creano le vere condizioni di marginalità. Non parliamo solo di famiglie vulnerabili in senso classico, ma anche di nuclei che semplicemente non riescono a rispondere a esigenze educative, relazionali, emotive sempre più complesse.
Lo abbiamo visto, per esempio, in alcune famiglie di origine cinese o nordafricana, che pur avendo imprese attive sul territorio, non trovavano in città servizi adeguati per accompagnare i figli con disabilità, al punto da prendere in considerazione l’idea di rimandarli nel paese d’origine. La questione, quindi, non era più solo “qual è il servizio?”, ma “come si forma un territorio ad accogliere?”, “quali strumenti possono capacitare le persone, le famiglie, le associazioni a leggere e gestire queste situazioni?”.
Da queste domande è nato Percorsi Divergenti, in risposta a un bando PNRR promosso dalla Città di Torino che invitava a progettare azioni sulla disabilità in una logica di coprogettazione. Ma noi abbiamo voluto impostare il lavoro in un altro modo: non creare un servizio per le persone neurodivergenti, ma costruire strumenti per far evolvere lo sguardo di chi abita e lavora sul territorio. Così è nato un percorso di formazione diffusa, rivolto a insegnanti, operatori, genitori e associazioni, con metodologie e linguaggi differenziati, perché non esiste una forma unica di comunicazione o un solo modello educativo.
Le associazioni che partecipano, con storie, dimensioni e culture diverse, hanno condiviso un processo complesso, ma fecondo: si sono formate, hanno messo in discussione le proprie pratiche, hanno lavorato insieme alla costruzione di nuove modalità di relazione. Il progetto ha generato anche azioni molto concrete: una tra tutte la riprogettazione dell’esperienza dell’“estate ragazzi”, a partire dalle segnalazioni dei genitori. In questo caso, l’obiettivo non era tanto quello di abbattere barriere architettoniche, ma di aumentare l’autonomia dei bambini e dei ragazzi attraverso una diversa organizzazione degli spazi, dei tempi, delle relazioni. Anche i volontari, spesso giovani o senza esperienza educativa, sono stati coinvolti in percorsi formativi per poter accompagnare con consapevolezza.
In tutto questo, il Fondo Sostiene Aurora ha avuto un ruolo cruciale: ci ha permesso di cofinanziare le attività, sostenere la formazione, garantire la presenza di figure educative preparate. Non si tratta di fare assistenza, ma di costruire legami e rafforzare il tessuto sociale, anche là dove è più fragile. Fare welfare di comunità, per noi, significa proprio questo: partire dalle condizioni reali – a volte difficili, a volte invisibili – e costruire intorno a esse processi collettivi di trasformazione, non servizi chiusi, ma strumenti comuni, capaci di generare fiducia e visione condivisa.



Comunità, alleanze e capitale sociale.
La Fondazione Comunità Porta Palazzo non nasce per erogare servizi, né per supplire alle mancanze dell’amministrazione pubblica, ma per attivare e connettere il capitale sociale di un quartiere denso, vitale e complesso come Aurora-Porta Palazzo. La sua forza non risiede nella disponibilità economica o nella struttura organizzativa, bensì nella capacità di agire come infrastruttura civica intermedia: uno snodo capace di intrecciare bisogni, competenze e risorse, generando fiducia, partecipazione e corresponsabilità. È da questa postura – né assistenziale, né sostitutiva – che la Fondazione ha costruito il suo ruolo politico e trasformativo all’interno della città.
Fin dai suoi primi passi, attraverso il manifesto costitutivo e dal piano strategico partecipato, la Fondazione si è posta come soggetto abilitante: un attivatore di reti di cura e mutuo aiuto, un catalizzatore di percorsi di auto-organizzazione dal basso, un interlocutore politico per la co-progettazione delle politiche locali. In questo quadro, il capitale sociale – inteso come tessuto di relazioni, fiducia e reciprocità – diventa il vero patrimonio collettivo su cui costruire trasformazione.
come Fuori di Palazzo, il Comitato Oltredora, Arcigay Torino, l’Associazione CoAbitare – promotrice del cohousing Numero Zero – ma anche scuole, gruppi informali, associazioni di migranti, piccole imprese, cooperative, centri culturali e presidi civici come il Cecchi Point. Tutti questi attori contribuiscono a costruire quella “intelligenza collettiva del quartiere” che la Fondazione riconosce come leva primaria della trasformazione.
Accanto al lavoro territoriale, la FCPP ha saputo stringere alleanze strategiche con grandi enti filantropici, come la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT, che ne hanno sostenuto l’avvio e ne riconoscono il valore di laboratorio urbano. La Fondazione partecipa inoltre a reti nazionali come Assifero – Associazione italiana delle fondazioni ed enti filantropici – e alla Biennale della Prossimità, confermandosi uno dei riferimenti più dinamici nel panorama italiano delle fondazioni civiche.
La governance è un altro tratto distintivo: trasparente, inclusiva, fondata sulla co-costruzione. Lo statuto prevede la partecipazione di soci fondatori, sostenitori e attivi, valorizzando chi agisce nei progetti e non solo chi aderisce formalmente. L’accesso non avviene per dichiarazione d’intenti, ma per impegno concreto. I gruppi di lavoro tematici – come quelli sull’abitare, lo spazio pubblico o la cura – sono aperti anche a chi non fa parte della Fondazione, purché si assuma una responsabilità reale. La struttura operativa lavora tre giorni a settimana, garantendo coordinamento, strumenti e accompagnamento.
Come abbiamo visto è dentro questa trama che si inserisce l’impegno verso la grave marginalità adulta, affrontata non come un tema settoriale ma come parte integrante della vita del quartiere. L’approccio della Fondazione rifugge tanto la logica caritatevole quanto quella specialistica. Non nasce per “occuparsi di”, ma per creare le condizioni affinché anche i soggetti più esclusi possano rientrare in relazioni significative, condivisioni di senso e pratiche quotidiane di cittadinanza. Esperienze come la riapertura del Giardino Pellegrino o la nascita dell’unità di strada al Sermig dimostrano come, da gesti minimi e da alleanze improbabili, possa nascere una politica dei legami capace di trasformare il modo in cui si abita uno spazio pubblico.
In questo scenario, la Fondazione non si limita a rivendicare diritti o a presidiare spazi, ma si pone come una vera leva civica: uno strumento generativo, al servizio di chi desidera agire per una giustizia territoriale. La valorizzazione dei beni comuni, la riattivazione di spazi in disuso, la costruzione di dispositivi di prossimità e di coabitazione – come nel caso del Community Land Trust o dei percorsi di Housing First – sono tutte espressioni di un approccio sistemico e situato, che coniuga visione e prassi, continuità e radicalità.
L’esperienza di Porta Palazzo, così come emerge dall’intervista, si propone allora come un modello ibrido e replicabile: non nel senso di un format esportabile, ma come metodo di lavoro, orientamento culturale, infrastruttura per l’attivazione. Una forma di politica relazionale che riconosce il valore dei territori come luoghi generativi, a patto che sappiano mettere in connessione persone, risorse, linguaggi e desideri. Perché, come emerge con chiarezza nelle parole di Cecilia Guiglia, per la Fondazione la cittadinanza non è un’identità statica, ma una pratica quotidiana di relazione e trasformazione.
Mario Flavio Benini. Guardando all’insieme delle vostre esperienze, mi domando quanto e come possano essere replicate in altri contesti. È chiaro che i territori hanno storie, culture e strutture diverse, e non è possibile trapiantare modelli in modo meccanico. Però alcune intuizioni, pratiche e impostazioni progettuali sembrano avere una forza generativa che potrebbe attivare processi simili anche altrove. Quali elementi pensa possano essere replicabili? E quali invece restano legati in modo più stretto al contesto in cui sono nati?
Cecilia Guiglia. Credo che ci siano almeno due condizioni di partenza che diventano fondamentali se si vuole immaginare una replicabilità, pur con tutte le necessarie declinazioni locali. La prima riguarda ciò che noi chiamiamo lo snodo: deve esserci già un pezzo di infrastruttura pubblica o para-pubblica, un punto di ancoraggio territoriale da cui partire. A Torino, questo ha significato avere le Case del Quartiere e l’esperienza di Torino Solidale. Strutture consolidate, dentro cui sono già sedimentati rapporti, conoscenze, linguaggi comuni. Luoghi come i Bagni Pubblici di Via Agliè, che sono stati un riferimento per il quartiere anche prima del nostro arrivo, e che rendono possibile ragionare sul cosiddetto “ultimo miglio”, adattando gli interventi alle specificità di una porzione di città senza dover ripartire da zero.
Il secondo elemento è culturale, ma anche operativo: partire da ciò che c’è, non da ciò che manca. In ogni quartiere esiste un tessuto associativo, magari poco visibile, magari stanco, ma quasi mai del tutto assente. E quel tessuto, anche se non composto da specialisti, è ciò che permette di costruire l’intreccio progettuale che serve. Ma non basta: serve anche un’interlocuzione con il pubblico. Può essere già strutturata, o magari solo disponibile. Ma deve esserci.
Per esempio, su alcune tematiche, noi lavoriamo insieme alla nostra “gemella”, l’altra Fondazione di Comunità di Mirafiori. Lì c’è un presidio pubblico importante: la fondazione gestisce anche lo sportello sociale, che è il punto di contatto diretto con la città. E allora si crea una sinergia. Su temi come l’abitare, la prevenzione degli sfratti, stiamo sviluppando pratiche comuni, condividendo strumenti, competenze, perfino équipe. Lo stesso accade con la Rete delle Case del Quartiere, dove stiamo cercando di portare, proprio sul tema casa, una metodologia che possa essere agita da ciascuna casa con le sue risorse, ma dentro un quadro comune.
Queste cose funzionano dove esiste già un sistema nervoso, dove i territori sono attraversati da reti. Penso, per esempio, a quello che sta accadendo a Roma con la rete dei Municipi. O a Milano, anche se la conosco meno. E naturalmente penso a Bologna, che per certi versi è stata per noi un modello. Lì hanno lavorato moltissimo sulla co-progettazione, sulla cultura civica, sull’idea che il pubblico non è solo quello che possiede, ma anche quello che genera valore condiviso. Abbiamo seguito una formazione con la Fondazione per l’Innovazione Urbana proprio per capire come declinare questi principi nel nostro contesto. Poi ognuno trova la sua forma: loro hanno un’altra storia, un’altra cultura amministrativa, un’altra base civica. Ma i principi si somigliano.
C’è però un altro elemento che fa davvero la differenza, e ce ne accorgiamo ogni giorno, anche nel confronto con chi lavora in contesti analoghi: serve una cittadinanza attiva che abbia un livello di competenza e una propria rete. Se oggi siamo in grado di costruire partenariati europei, progettare in due mesi nonostante agosto in mezzo, è anche perché alcune persone, pur da volontarie, portano con sé competenze specifiche. Due lavorano all’università, un’altra ha una rete internazionale. E anche io, per esempio, ho collaborazioni con colleghi e compagni che vivono altrove, che posso attivare rapidamente.
Tutto questo non è retribuito, non è lavoro in senso stretto, ma è attivismo civico. È un volontariato che si muove su un altro piano rispetto a quello tradizionale, e che però è decisivo. Non tutti i territori lo hanno, ed è uno dei punti che la nostra omologa, la Presidente dell’altra Fondazione di Comunità, ha messo in rilievo. Lei stessa si rende conto che è difficile, nel suo contesto, chiamare a raccolta competenze di questo tipo. Anche perché la filantropia tradizionale spesso cerca un’altro tipo di risorse: chi sa gestire i fondi, chi sa amministrare, chi viene dal mondo bancario. E in effetti molte Fondazioni sono piene di volontari bravissimi nel tenere i conti, ma meno preparati per immaginare o costruire innovazione sociale.
Noi invece ci siamo detti che se vogliamo cambiare davvero il modo in cui una Fondazione di Comunità lavora, dobbiamo cambiare anche le persone che la attraversano. E allora andiamo a cercarle, e spesso le troviamo. Perché in giro ci sono tante persone competenti, disponibili, capaci. Solo che bisogna sapere di averne bisogno, e attivarsi per costruire quella rete.
A Torino abbiamo due realtà che sono, secondo me, uniche almeno in Italia, forse anche nel mondo. Camminare Insieme, con i suoi 570 medici volontari, è un esempio straordinario. E lo è anche la Pastorale dei Migranti, che riesce a mobilitare più di 200 volontari, tra cui un ex sindaco e un ex direttore del Teatro Regio, persone che fanno la distribuzione dei pacchi alimentari, ma che non si limitano a questo. Intorno a quelle attività si costruiscono legami, relazioni, reti. E quando si tratta di progettare, di innovare, sanno dove attingere.
Questi, secondo me, sono gli elementi fondamentali: uno si può strutturare, l’altro si può costruire. E quando ci sono entrambi, allora sì che il nostro modello è replicabile.
Per il resto, è una questione di cultura, di visione, anche di narrazione. Oggi abbiamo accesso a tante informazioni, a tanti strumenti. Nessuno di noi viene dal mondo cattolico, per dire, ma abbiamo capito che dovevamo leggere la rivista Vita. Perché lì c’era un pezzo di mondo che parlava di noi, anche se con un altro linguaggio.
La piattaforma online Italia che Cambia sta provando a fare qualcosa in quella direzione, ma è difficile. C’è bisogno di nuove forme di racconto, che parlino anche a chi ancora non è dentro, non è attivo. Noi abbiamo parlato anche con loro, ci hanno chiesto di affidarci a loro per la comunicazione, ma non abbiamo ancora le risorse per farlo. Però è un discorso aperto.
Serve qualcuno che sia capace di approfondire, ma anche di farti leggere cinque righe che ti accendano una scintilla. Perché il tempo è poco, le informazioni sono troppe, e il rischio è perdersi. Invece abbiamo bisogno di strumenti semplici, leggibili, che aprano porte. Poi ciascuno va in fondo dove vuole, ma deve poter cominciare da qualcosa di essenziale. Anche questo, in fondo, è parte della sfida.
Mario Flavio Benini. Dal lavoro di ricerca in corso, una cosa che mi è balzata subito all’occhio è che in Italia esistono esperienze davvero interessanti. Penso, ad esempio, al progetto Dar=Casa a Milano: un’ esperienza che, pur non focalizzandosi direttamente sulla grave marginalità adulta, lavora con fragilità complesse e lo fa costruendo pratiche di cittadinanza, partecipazione e prossimità.Quel che mi colpisce in alcune di queste esperienze – anche nella vostra – è la capacità di partire dalla sperimentazione concreta, senza perdere però una visione civica ampia, capace di attivare meccanismi collettivi. Ed è proprio su questo punto che, secondo me, si gioca una delle sfide principali: riuscire a raccogliere il pensiero diffuso che emerge dai territori e trasformarlo in visione, senza appiattirlo. Mi viene da pensare anche ad alcune esperienze di Housing First, come quella di PsyPlus a Roma, che nasce da un gruppo di lavoro di psicologi e psicanalisti che ha scelto di misurarsi con la grave marginalità, puntando su modelli abitativi non assistenzialisti. Il limite, però, almeno per come l’ho osservata io, è la mancanza di una relazione strutturata, profonda, continua con il territorio. Perché una cosa è certa: non si può lavorare davvero sulla condizione di chi ha perso tutto se non si ricostruisce un tessuto relazionale, se non si riattivano i legami con una comunità. Le persone che vivono in strada non sono semplicemente “senza casa”: sono anche profondamente mancanti di relazioni non effimere. Per questo credo che mettere in relazione pratiche diverse – come quelle di chi lavora sull’abitare, con chi si occupa di lavoro, salute, cittadinanza – potrebbe generare modelli nuovi, più efficaci di quelli attuali. Modelli che tengano insieme le competenze e le relazioni umane. Altrimenti, restiamo con esperienze magari ben fatte, ma poco trasformative.
Cecilia Guiglia. Che ci sia un tema di fondo, sì, e non è solo politico. Io credo che ci muoviamo dentro una questione culturale più ampia, che va ancora oltre il piano politico. Quello che è successo negli ultimi vent’anni è che si è prodotta una crescente specializzazione del lavoro sociale, spesso accompagnata da pratiche di impresa che, giustamente, hanno cercato sostenibilità economica e riconoscimento professionale. E questo ha portato alla nascita di esperienze straordinarie, anche a livello europeo, che hanno spostato l’asticella in alto.
Ma nello stesso tempo, questo processo ha assorbito tante energie che, fino a qualche anno fa, erano più liberamente disponibili nei territori. Ha “succhiato” verso l’alto molte delle persone che si sarebbero potute attivare come cittadini, e che invece sono diventati operatori, dirigenti, tecnici. E questo non è un male in sé, anzi. Ma ha avuto un effetto collaterale importante: la disattivazione di una cittadinanza che dona competenze al territorio.
In fondo, è come se avessimo tolto di mezzo la possibilità, per chi non è “del mestiere”, di essere parte di un processo trasformativo. Anche nelle forme della prossimità. Perché oggi, se vuoi fare qualcosa di efficace, ti servono competenze, accesso ai fondi, capacità progettuali, conoscenza dei dispositivi pubblici. Ed è difficile immaginare che tutto questo possa stare sulle spalle di un cittadino, per quanto motivato.
Ne parlavamo anche alla Biennale della Prossimità. All’inizio erano quasi solo cooperative a partecipare. Oggi, invece, si stanno affacciando anche altri soggetti, che provano a ripensare la prossimità non solo come “lavoro sociale ben fatto”, ma come forma di cittadinanza attiva, capace di mettere insieme professionalità e senso. Non si tratta di rifiutare il lavoro retribuito – ci mancherebbe – ma di evitare che la prossimità diventi un’ennesima delega verticale.
Perché il punto è proprio questo: se vogliamo che la prossimità diventi qualcosa di generativo, dobbiamo costruire forme ibride, dove la competenza non sia egemonica e dove la cittadinanza non sia ridotta all’animazione.
E su questo, per me, l’esempio della Caritas è molto eloquente. Lo dico con grande rispetto: oggi dentro Caritas c’è una frattura reale, in parte ancora sommersa, tra la dimensione professionalizzata e quella delle parrocchie. C’è chi ha spinto verso un modello sempre più tecnico, strutturato, con professionisti formati, bandi, progettualità complesse. E c’è chi invece sente che, così facendo, si è perso qualcosa. Il legame con le comunità. La forza delle relazioni dirette. Il volto umano della prossimità.
Eppure quella professionalizzazione era necessaria. Per uscire dalla pura assistenza, per costruire percorsi di autonomia, per evitare che tutto ricadesse sulle spalle del volontariato spontaneo. Ma, al tempo stesso, ha prodotto nuove distanze. Perché se quella figura resta solo un professionista, il rischio è che la relazione si sposti sul piano del servizio, e non della reciprocità.
E allora vedi che torniamo al tema di fondo: costruire relazioni tra dispari. Perché sì, io non sono pari alla persona senza dimora che vive in Piazza della Repubblica. E non mi illudo di esserlo. Ho un potere che quella persona non può nemmeno immaginare. E sarebbe ipocrita fingere che non sia così.
Ma proprio per questo, se entro in relazione come cittadina – con tutte le mie contraddizioni, i miei dubbi, le mie fragilità – forse riesco ad aprire uno spazio diverso. Uno spazio dove anche l’altro può portare qualcosa. Non perché diventa mio pari, ma perché insieme generiamo qualcosa che da soli non potremmo produrre.
E allora serve un’infrastruttura, certo. Servono risorse, strumenti, saperi. Ma serve anche una disponibilità ad abitare quello spazio intermedio, dove non sei né tecnico né volontario, ma qualcosa di più profondo: sei una persona che si mette in gioco, che costruisce legami, che partecipa.
E forse è proprio lì che si può tornare a fare politica. Nella forma più bella che conosciamo: stare e condividere percorsi di trasformazione con gli altri anche quando sono lontanissimi da noi.
Mario Flavio Benini. Il problema della professionalizzazione accomuna un po’ tutte le grandi realtà del Terzo Settore che si occupano di grave marginalità adulta. Anche perché, poi, questo lo si vede chiaramente nelle pratiche messe in campo: si assomigliano tutte. Al di là di rari esperimenti, magari anche interessanti ma ancora piccoli, il grosso del lavoro sembra muoversi sempre su binari simili, con un dialogo politico spesso standardizzato e un orientamento dei finanziamenti che segue sempre le stesse traiettorie. Mi pare ci sia una relativa attenzione, se non proprio una mancanza di ascolto, verso le vere problematiche delle persone che vivono condizioni di marginalità estrema. Manca un dialogo reale, c’è tanta professionalizzazione, molta rincorsa ai fondi, e una progressiva smobilitazione di quello spirito iniziale che invece lei poco fa evocava con forza.
Cecilia Guiglia. Capisco perfettamente quello che dice, ma mi sento anche di dire con forza che non possiamo continuare a scaricare sul Terzo Settore responsabilità che sono pubbliche. Non possiamo chiedere alle imprese sociali di farsi carico della costruzione e del sostegno delle infrastrutture sociali di un territorio. Perché quello è compito delle istituzioni. È il pubblico che dovrebbe garantire quei presìdi, quelle condizioni minime che rendano possibile un lavoro di prossimità non occasionale, non lasciato al caso, non appeso ai bandi o alla buona volontà di singoli soggetti.
Il Terzo Settore ha già pagato due crisi economiche. E non solo in termini finanziari. Ha pagato in termini di dignità del lavoro. Perché oggi il lavoro sociale è tra i meno retribuiti che esistano, e non perché le cooperative “si prendono tutto”, come qualcuno pensa. Basta guardare le gare d’appalto: i prezzi sono pubblici, i compensi sono dichiarati. La verità è che le risorse sono scarsissime e i costi del disinvestimento pubblico ricadono sistematicamente sugli operatori e sui territori.
È una dinamica che denuncio da tempo anche in altri contesti, come nel comitato promotore della Biennale della Democrazia. C’è una forma di riconoscimento simbolico da parte del pubblico – ti danno la sala, ti ringraziano, ti lasciano lavorare – ma poi non mettono a disposizione risorse vere, non entrano nel merito, non si assumono la responsabilità di una regia.
E il paradosso è che siamo a Torino, una delle città italiane più avanzate sul piano della partecipazione. Dove esiste da vent’anni una rete delle Case di Quartiere, dove si è costruito Torino Solidale, dove ora si sta tentando di rilanciare Torino Plurale. Eppure, quando si fa la coprogrammazione sul piano per l’inclusione sociale, la rete delle Case non è neppure invitata. Viene invitato un sindacato. Questo, per me, è il segno di una mancanza culturale: non si è ancora compreso davvero cosa significhi fare prossimità, strutturare un presidio relazionale, costruire una governance diffusa.
Se il pubblico non fa la sua parte, tutto resta affidato alla “fortuna” dei territori: più o meno ricchi di associazioni, di volontari, di reti. Più o meno capaci di reggere il peso del vuoto istituzionale. E quando parlo di ricchezza non mi riferisco solo a risorse economiche, ma anche alla densità relazionale, al capitale sociale, alla presenza di cittadini competenti e motivati.
Pensi a quello che è accaduto con il bando per le reti territoriali per l’autonomia. Ci hanno convocato all’improvviso, ci hanno chiesto di lavorare tutti pancia a terra per venti giorni, abbiamo costruito alleanze, risposto con entusiasmo. E poi? Poi è sparito tutto. Nessuna comunicazione ufficiale, nessuna graduatoria. Hanno ricevuto troppe domande, ci è stato detto. Ma se ricevi tante proposte valide, non chiudi il bando. Le valorizzi. Ti fermi, chiami i soggetti, li ascolti, li metti in relazione tra loro. Non cestini tutto.
Per questo, torno a dire: il pubblico deve fare il suo pezzo. Altrimenti restano solo isole. Belle, magari, anche molto efficaci, ma sempre isole. E le isole non fanno sistema.
Se non c’è un investimento strutturale, se non si mettono a disposizione spazi, risorse, processi condivisi, allora le esperienze restano frammenti.
E la responsabilità non può ricadere, ancora una volta, su chi da anni tiene insieme i pezzi.
Mario Flavio Benini. Uno degli ostacoli più rilevanti per chi prova a costruire progettualità sociali stabili, soprattutto nell’ambito della grave marginalità, è rappresentato dalla rigidità degli strumenti finanziari oggi disponibili. Molte esperienze che abbiamo incontrato si trovano costrette a inseguire bandi con tempi e logiche che poco si adattano alla complessità e ai bisogni delle persone coinvolte. È difficile, per esempio, impostare un progetto di Housing First su base annuale quando parliamo di percorsi di vita che richiedono continuità, accompagnamento lungo, e una forte adattabilità. Eppure, è come se il sistema pubblico non riuscisse ancora a strutturare strumenti coerenti con queste esigenze.
Alla luce della vostra esperienza, anche come Fondazione di Comunità, quali sono secondo lei gli snodi critici e le possibili vie d’uscita? Servono strumenti nuovi? O basterebbe usare meglio quelli che abbiamo?
Cecilia Guiglia. Secondo me uno dei fattori che ha inciso positivamente nel nostro percorso è stata la scelta, forse un po’ fortunata ma anche molto consapevole, di adottare la forma giuridica della Fondazione. È una scelta che ci ha aperto non solo a possibilità operative diverse, ma soprattutto a una rete di scambi culturali e di riflessione, sia a livello nazionale che internazionale. Le fondazioni, a differenza di altre forme, hanno accesso a luoghi in cui si discute, in cui si condividono visioni, si accumula esperienza. E in quegli spazi – in particolare nel mondo della filantropia – il tema che lei solleva è molto presente. È un tema riconosciuto, discusso, su cui esiste una consapevolezza diffusa: nei finanziatori, nelle fondazioni bancarie, ma anche tra gli amministratori pubblici più attenti.
Non è qualcosa che dobbiamo ancora analizzare. Anzi, ci sono già percorsi in atto. Ad esempio, si sta lavorando per spostare l’attenzione dal “rendicontare” al “rendere conto”, cioè costruire relazioni basate sulla fiducia e non solo su indicatori numerici. Questo non significa assenza di controllo, ma significa cambiare paradigma: riconoscere che il valore di certi progetti non si misura solo con i numeri o con il cronometro, ma con la qualità delle relazioni, con la continuità dei processi, con il radicamento.
Anche a Torino questa consapevolezza comincia a prendere forma. Il Piano di Inclusione Sociale, che è lo strumento attraverso cui oggi il Comune veicola una parte consistente delle sue politiche sociali, si sta strutturando in modo più articolato. È come un grande desktop dove vengono aperte aree tematiche, su ciascuna delle quali si definiscono priorità, obiettivi, ambiti di intervento. E su questi si fanno le chiamate pubbliche. Le fonti di finanziamento possono essere le più diverse: PNRR, fondi europei, fondi ministeriali, fondi locali. Ma la gestione amministrativa la fa il Comune: significa che la rendicontazione è centralizzata, e per chi partecipa diventa tutto molto più semplice.
Certo, non tutto è perfetto. Ma già il fatto che si ragioni su una durata pluriennale – e non più solo annuale – è un passo avanti. Noi, ad esempio, abbiamo avuto confronti molto franchi con il Comune di Torino proprio su questo tema. Alcune misure possono rimanere annuali, ed è anche giusto: penso agli aiuti per le morosità incolpevoli, alle piccole misure di supporto che funzionano anche con questa scansione. Ma ci sono altre dimensioni che richiedono una progettazione più lunga. Per questo, ad esempio, la Compagnia di San Paolo ha deciso di sostenere le Fondazioni di Comunità con un bando biennale, che quest’anno è diventato persino un “due più uno”: due anni garantiti più un terzo opzionale, proprio per dare respiro.
Certo, per il pubblico tutto questo è più complesso. I bilanci sono annuali, i margini di manovra stretti. Torino, poi, ha vissuto anni difficilissimi dopo le Olimpiadi: un pre-default che si è protratto fino al governo Draghi. Solo recentemente si è cominciato a respirare un po’. E quindi sì, bisogna essere realisti. Ma è proprio per questo che serve costruire strumenti nuovi, patti diversi, forme ibride.
La coprogettazione e la coprogrammazione potrebbero essere la chiave, ma vanno usate davvero, non solo citate nei documenti. E soprattutto serve chiarezza. Se la città decide che su certi ambiti ogni anno ci saranno delle misure, benissimo: ma dev’essere chiaro, trasparente, partecipato.
Il problema, a ben vedere, non è solo la durata delle risorse. È il personale. Cioè, la macchina pubblica oggi non ha la forza – né quantitativa né qualitativa – per gestire l’innovazione. E questo è un problema strutturale. Faccio un esempio banale: il settore casa, a Torino, è stato per anni praticamente smantellato. Un solo funzionario attivo, senza un dirigente, senza supporto. Solo negli ultimi tre anni, grazie a una piccola finestra aperta dal Comune, sono arrivati alcuni lavoratori interinali. E con loro si è lavorato, si sono fatti miracoli. Ma miracoli non bastano. Perché bastano un numero sbagliato, una stima errata, e i fondi si bloccano.
E noi non possiamo dare la colpa a quei funzionari, perché sappiamo perfettamente che lavorano in condizioni estreme. Stanno lì un anno, imparano come funziona, e poi se ne vanno. Come si fa innovazione così? Come si costruisce una strategia? È una macchina che ogni volta deve ripartire da capo.Io, su questo, sono stata d’accordo persino con Draghi: se vogliamo che il nostro Paese funzioni davvero, dobbiamo investire nella pubblica amministrazione. Non solo nei numeri, ma nelle competenze. Non possiamo pensare che tutto il peso della rigenerazione sociale ricada su chi sta fuori.
Se io, da soggetto territoriale, vado in Comune, devo trovare qualcuno che conosce il territorio, che sa dirmi a chi rivolgermi, che mi orienta. Non pretendo che faccia tutto, ma che almeno conosca la mappa. Che sappia chi può aiutarmi, chi fa un lavoro simile, chi ha risorse.
E quando questo accade – come accade, per esempio, con l’ufficio stranieri, con il Piano di Inclusione Sociale che è riuscito ad attivare risorse grazie anche alla Prefettura – i risultati si vedono. Perché lì c’è stato un investimento vero, continuo, e oggi quella macchina funziona. Ti ascoltano, ti connettono, uniscono i puntini. È questo il tipo di interfaccia che serve. È questo che può fare la differenza.
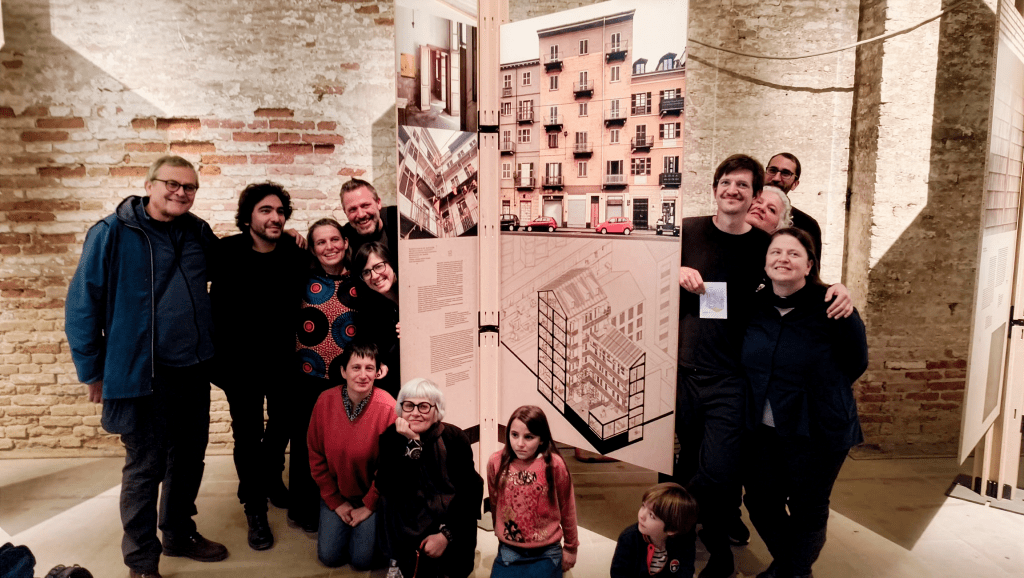

Il Community Land Trust Torino.
Tra i progetti più ambiziosi e innovativi della Fondazione Comunità Porta Palazzo, il Community Land Trust (CLT) Torino rappresenta una svolta radicale nel modo di intendere l’abitare. È il primo esperimento italiano di questo genere e uno dei pochi in Europa continentale ad aver raggiunto la piena operatività. Nato dall’incontro tra attivatori civici, urbanisti, giuristi, realtà di base e la stessa Fondazione, il progetto è stato formalizzato nella creazione della Fondazione Community Land Trust – Terreno Comune ETS, soggetto giuridico dedicato che ne ha assunto la titolarità e la gestione concreta.
L’obiettivo è tanto semplice quanto rivoluzionario: acquistare e rigenerare uno stabile nel cuore di un quartiere popolare, mantenendo la proprietà collettiva del suolo attraverso la formula del diritto di superficie perpetuo, e vendendo gli alloggi a prezzi calmierati a famiglie escluse sia dal mercato privato che dall’edilizia pubblica. Il progetto pilota si sviluppa in Corso Giulio Cesare 34, nel quartiere Aurora, e prevede la ristrutturazione di 16 appartamenti, con una governance tripartita e vincoli di rivendita antispeculativi.
Il CLT agisce su tre livelli fondamentali. Giuridicamente, separa la titolarità del suolo (che resta alla Fondazione) da quella degli alloggi (ceduti in diritto di superficie), grazie a un impianto costruito su misura per il diritto italiano con la consulenza del giurista Antonio Vercellone. Economicamente, permette l’accesso alla casa a famiglie con redditi tra 1.300 e 1.500 euro mensili, mantenendo il costo complessivo dell’abitare entro 500 euro mensili, quindi sotto il terzo del reddito. Socialmente, attiva un processo di accompagnamento partecipato, selezionando le famiglie tramite bando pubblico, costruendo un percorso di convivenza, promuovendo governance condivisa e responsabilizzazione reciproca.
L’avvio del progetto è stato reso possibile dalla partecipazione di 81 cittadini e 5 enti, che hanno contribuito all’acquisto dell’immobile tramite prestiti sociali, senza ricorso a mutui bancari. I costi di ristrutturazione saranno invece coperti tramite l’accesso al credito da parte delle famiglie acquirenti, donazioni e la cessione agevolata di alcuni alloggi a partner sociali. La festa di comunità che ha celebrato l’acquisto dello stabile nel 2024 ha rappresentato un momento altamente simbolico: un gesto collettivo, pubblico, di restituzione di fiducia e visione del futuro.
Il progetto è nato con il supporto di una consulta di quartiere, che ha coinvolto istituzioni pubbliche, università, enti filantropici e associazioni territoriali nel processo di costruzione del bando e nella definizione dei criteri di selezione delle famiglie. Il CLT non è quindi solo un esperimento immobiliare, ma un’infrastruttura civica che mette in comune competenze, visioni e responsabilità. In alcuni casi, i destinatari del progetto si trovano in condizioni di fragilità estrema o in transizione, con percorsi ai margini della residenza anagrafica o a rischio di esclusione abitativa, intercettando così anche la soglia della homelessness.
L’esperienza torinese si confronta e si ispira a modelli consolidati a Boston, Bruxelles, Londra, Barcellona, Vienna, Seoul, dove le forme di proprietà collettiva e di cooperazione abitativa stanno ridisegnando i margini della città, promuovendo giustizia spaziale e diritto all’abitare. Tuttavia, il CLT di Torino non si limita a importare questi modelli: li adatta e reinventa per un contesto urbano ad alta fragilità, come Aurora, dove l’inclusione è una sfida quotidiana e la fiducia sociale una risorsa da costruire passo dopo passo.
Mario Flavio Benini. Il Community Land Trust di Torino è il primo progetto operativo di questo tipo in Italia. Come è nata l’idea e quali sono stati i passaggi decisivi che vi hanno permesso di concretizzarla?
Cecilia Guiglia. L’idea di sperimentare un Community Land Trust è nata all’interno di un percorso di studio e confronto con esperienze europee che cercavano – ciascuna a modo proprio – di costruire risposte abitative sganciate dalla logica speculativa del mercato immobiliare. Il nodo per noi era proprio questo: come garantire il diritto alla casa, migliorando la qualità dell’abitare, senza diventare complici di un processo di gentrificazione? Come si può riqualificare un edificio o uno spazio urbano senza espellere le persone fragili che lo abitano?
Da lì è cominciata una ricerca, e due modelli ci hanno colpito particolarmente. Da un lato, l’esperienza del Mietshäuser Syndikat tedesco; dall’altro, quella dei Community Land Trusts britannici. Il Syndikat ha un’impostazione molto radicale e interessante: mette insieme l’autogestione locale degli inquilini e una struttura centrale, la GmbH, che detiene una quota di minoranza ma fondamentale per impedire la vendita degli immobili sul mercato. Questo meccanismo consente di bloccare la speculazione, mantenendo però la piena autonomia abitativa e organizzativa di ciascun gruppo locale.
Però è un modello che funziona se c’è già una rete attiva, e in Italia – al momento – mancavano le condizioni minime per riprodurlo. Ci sarebbe voluto molto più tempo, più forze, e anche una capacità di autorganizzazione dal basso che qui non è ancora così strutturata. Così abbiamo guardato con maggiore attenzione al modello del Community Land Trust anglosassone, che ci è parso più adatto a un contesto come il nostro. Lì la leva è sempre la proprietà collettiva del suolo, ma la gestione è affidata a un trust comunitario che garantisce l’inalienabilità del bene e la permanenza nel tempo della funzione sociale dell’abitare.
In questa direzione abbiamo cominciato a muoverci, cercando di adattare quel modello a Torino e alla nostra esperienza, tenendo comunque aperto il dialogo con altre realtà italiane che stanno sperimentando forme più radicali di coabitazione, mutualismo e governance collettiva. A noi interessa anche sostenere questi tentativi, e far sì che il nostro progetto – già operativo – possa diventare un riferimento utile, soprattutto per chi oggi è ancora in fase di ideazione.
Mario Flavio Benini. State lavorando anche dentro una rete nazionale? È già attiva?
Cecilia Guiglia. Sì, stiamo partecipando a una rete informale che mette insieme alcune esperienze italiane che si ispirano, in forme diverse, al modello del Mietshäuser Syndikat. Al momento è una rete in fase di studio e confronto, ma ci sono già dei gruppi attivi, soprattutto in Piemonte, Trentino e Lombardia. A Torino, per ora, il nostro è l’unico progetto operativo; in Piemonte un altro gruppo ha recentemente portato a termine un acquisto collettivo, e si sta confrontando proprio con la rete tedesca. In Trentino c’è molto fermento, e non è un caso: lì i contatti con il Syndikat sono più avanzati, anche per ragioni linguistiche e culturali.
È un ecosistema che si sta muovendo, ma restano ancora aperte molte questioni giuridiche e fiscali. In Italia, oggi, non è semplice dare forma legale a certe esperienze: anche quando si prova a utilizzare strumenti come le società benefit o le SRL con vincoli sociali, si resta dentro un quadro normativo ancora poco chiaro, soprattutto rispetto alla fiscalità. Questo rende complicato costruire dei modelli ibridi che siano realmente sostenibili. E finché la riforma del Terzo Settore non avrà completato il suo percorso, sarà difficile immaginare un riconoscimento pieno di queste pratiche.
Mario Flavio Benini. Quindi questa rete non ha ancora assunto una forma organizzativa definita?
Cecilia Guiglia. No, al momento è una rete del tutto informale. Non è stata costituita come soggetto giuridico, né come coordinamento strutturato. Si sta ancora cercando una forma adatta, che permetta di promuovere, accompagnare e diffondere questo tipo di esperienze, senza snaturarne la natura partecipativa. È una rete che si dà parola, si scambia conoscenze, osserva quello che succede altrove, e si confronta su come adattare modelli internazionali al contesto italiano.
Per quanto riguarda noi, siamo arrivati a un punto in cui abbiamo già affrontato diverse tappe importanti – dalla costruzione del trust alla definizione della missione sociale – ma ci restano ancora da mettere a terra alcuni passaggi decisivi, soprattutto quelli legati alla vendita, alla gestione pluriennale e alla protezione dell’inalienabilità. È un lavoro che richiede tempo, confronto continuo e molta cura. Ma siamo convinti che valga la pena farlo, anche perché può aprire una strada nuova, non solo per Torino.
Mario Flavio Benini. Il supporto giuridico del professor Vercellone è stato importante: quali sono state le principali sfide normative e come le avete affrontate e superate?
Cecilia Guiglia. Finora abbiamo portato avanti un lavoro di fattibilità, sia dal punto di vista giuridico che fiscale. Questo percorso ha coinvolto direttamente il giurista Antonio Vercellone, che ha studiato a fondo il modello dei Community Land Trust a livello internazionale, e che ha pubblicato in Italia un vero e proprio manuale sull’argomento, oggi insegnato anche all’università. Accanto a lui abbiamo coinvolto uno studio notarile che ha creduto nel progetto e ha deciso di accompagnarci in questa sperimentazione. E poi le nostre commercialiste, specializzate nel terzo settore e con cui collaboriamo stabilmente come Fondazione: vengono dalla Lombardia e hanno giocato un ruolo essenziale nella verifica di fattibilità.
Dall’incrocio di queste competenze è emersa una prima grande indicazione: la forma giuridica più adatta a sostenere un CLT in Italia è, paradossalmente, proprio quella della Fondazione. È l’unica struttura che consente oggi di disegnare in modo veramente autonomo e libero la governance. Questo la distingue nettamente da associazioni, comitati o cooperative, dove gli statuti sono molto più vincolati da forme codificate. La Fondazione, invece, può costruire un sistema di governo articolato secondo finalità proprie, e questo è fondamentale per un CLT, perché la governance è parte stessa del meccanismo di tutela dal rischio di alienazione dei beni comuni.
Nel nostro caso, abbiamo quindi previsto una governance tripartita: da una parte gli abitanti (che saranno proprietari degli immobili), dall’altra i soggetti del territorio (quelli che abitano o lavorano intorno all’intervento), e infine i portatori di interesse pubblico (istituzioni, enti, esperti, ecc.). Questo assetto garantisce che le decisioni non siano monopolizzate da un solo gruppo di interesse e che il bene resti protetto nella sua destinazione collettiva. La forma della Fondazione rende possibile tutto questo.
Dal punto di vista fiscale, abbiamo poi potuto verificare che se una Fondazione ha tra i propri scopi statutari quello dell’abitare sociale o dell’housing sociale – come nel nostro caso – allora può essere considerata soggetto di interesse generale secondo il Codice del Terzo Settore. Questo significa che anche quando acquista, vende o ristruttura immobili, non è obbligata ad aprire una partita IVA commerciale. È una condizione essenziale, perché consente di evitare tassazioni ingiustificate su eventuali differenziali di valore tra acquisto e rivendita, tra pre e post ristrutturazione, o tra acquisto e successiva cessione. In breve: se l’attività viene svolta coerentemente con lo scopo di interesse generale, allora rientra nelle attività istituzionali della Fondazione, anche se comporta movimentazioni economiche importanti.
Un’altra questione centrale ha riguardato il cuore stesso del modello CLT: la separazione tra proprietà del suolo (che resta in capo alla Fondazione) e proprietà dell’immobile (che può essere ceduta a singole famiglie). Questo principio, che è il cuore del modello, non è affatto estraneo alla legislazione italiana: esperienze di edilizia convenzionata su suolo pubblico o in cooperativa hanno fatto qualcosa di simile. Tuttavia, in Italia, la prassi è stata quella di riunificare le due proprietà allo scadere del vincolo (di solito a 99 anni), e quindi uno dei grandi interrogativi giuridici è stato proprio questo: come impedire che, in futuro, qualcuno – un privato o una banca – possa chiedere la riunificazione delle due proprietà invocando il principio della tutela della proprietà privata, che da noi è molto forte?
La risposta sta proprio nella configurazione della Fondazione come soggetto di interesse generale, e quindi nel fatto che lo scopo dell’abitare sociale diventa, anche giuridicamente, un elemento di tutela pubblica. In questo modo si può giustificare la permanenza del vincolo e la difesa della struttura proprietaria duale anche di fronte a possibili contenziosi.
Ma non è finita qui. Un altro nodo delicatissimo è stato quello dei vincoli di utilizzo: il CLT è una forma proprietaria, ma vincolata. Chi acquista un appartamento, infatti, può rivenderlo solo alla Fondazione o a un altro soggetto individuato dalla Fondazione, selezionato all’interno di una graduatoria di accesso. Inoltre, il prezzo di rivendita è limitato: non segue il mercato, ma una formula di rivalutazione che garantisce una piccola crescita del valore – tutelando l’investimento della famiglia – ma impedisce speculazioni. Stiamo ancora definendo la formula precisa, perché ci sono molti modelli possibili, ma abbiamo già scritto nello statuto, nella parte immutabile, che la rivalutazione non potrà mai superare il 20%.
Terzo vincolo: l’immobile non può essere affittato né lasciato vuoto per lunghi periodi. Deve essere abitato da chi lo acquista, salvo situazioni di forza maggiore. Tutto questo è fondamentale per mantenere la funzione sociale del bene.
Ovviamente, queste condizioni – pur tutelando la comunità – possono spaventare le banche, che sono molto caute quando si tratta di erogare mutui. Il timore è che, in caso di insolvenza, non riescano a rivalersi su un bene con vincoli così stringenti. Una delle sfide è stata proprio questa: costruire una modalità giuridica che consentisse di far coesistere i vincoli con la possibilità per le banche di concedere mutui.
La soluzione che abbiamo trovato con il notaio è stata quella di inserire i vincoli successivamente all’atto di mutuo: il rogito contiene una clausola che prevede l’inserimento dei vincoli solo dopo l’erogazione del mutuo. In questo modo, la banca non può opporsi formalmente. Ma, al tempo stesso, abbiamo previsto un meccanismo di protezione: la Fondazione si impegna, in caso di default, a riacquistare l’immobile prima che venga messo all’asta. Per evitare che questo generi nuovi costi eccessivi, abbiamo immaginato uno strumento mutualistico: ogni famiglia verserà mensilmente una piccola quota, una “fee”, che andrà a costituire un fondo di garanzia. A questo si aggiungerà una quota aggiuntiva che alimenterà un fondo comunitario, utilizzabile in caso di difficoltà nel pagamento delle rate. Al momento, abbiamo ipotizzato che si possa attivare dopo tre mensilità non pagate.
Mario Flavio Benini. Quindi un sostegno nel momento in cui le persone non riescano a pagare la rata per tre mesi consecutivi?
Cecilia Guiglia. Esattamente. L’idea è di usare questo tempo – tre o quattro mesi – per intervenire insieme al nucleo familiare, capire se la difficoltà è transitoria e superabile o se è necessario pensare a un’altra soluzione abitativa. In ogni caso, la priorità è evitare che le persone perdano i risparmi investiti e che l’immobile venga sottratto al circuito comunitario.
Mario Flavio Benini. Nel caso di decadenza, quindi, l’immobile viene riacquistato dalla Fondazione?
Cecilia Guiglia. Sì, è questa la soluzione che al momento abbiamo pattuito con le banche. Ovviamente speriamo non accada, e va detto che i dati internazionali sono confortanti. Negli Stati Uniti, durante la crisi dei mutui subprime, il tasso di insolvenza nei CLT è stato inferiore al 4%, a fronte di percentuali molto più alte nel mercato libero. Questo dimostra che il modello funziona anche in termini di sostenibilità economica. In altri paesi, esistono formule alternative che evitano la riacquisizione da parte del CLT, ma per noi, al momento, questa è la strada più praticabile.
Il confronto con Banca Etica è stato prezioso. Abbiamo scoperto quanto la normativa attuale – dopo la crisi del 2008 – abbia ridotto l’autonomia delle banche nella concessione dei mutui. Esistono regole interbancarie molto rigide, imposte anche da Banca d’Italia, che hanno ridotto la platea di chi può ottenere un mutuo. Non bastano più buone intenzioni: servono redditi stabili, contratti a tempo indeterminato, garanzie familiari. Molti dei potenziali destinatari del nostro progetto – famiglie monoreddito con minori – oggi non rientrano nei criteri.
È per questo che in passato il governo italiano ha attivato dei fondi di garanzia per facilitare l’accesso al credito per la prima casa. Tuttavia, questi fondi risarciscono la banca, non la persona, e possono essere sospesi da un anno all’altro con la Legge di Bilancio. Anche per questo, è importante continuare a lavorare su strumenti alternativi, come quelli che stiamo costruendo.
Infine, abbiamo curato molto anche la fattibilità tecnico-economica del progetto. In questo ci ha supportati Avanzi, una società milanese con grande esperienza. Il loro apporto è stato cruciale per mettere a punto un business plan coerente e realistico. Noi avevamo fatto delle ipotesi, ma serviva una competenza tecnica molto solida. La nostra operazione è stata pensata per famiglie monoreddito con figli minori, perché sono tra i soggetti più esclusi dal mercato immobiliare. Anche su questo, ogni dettaglio economico – costi, margini, sostenibilità – è stato verificato.
Mario Flavio Benini. Il vostro target sono famiglie che non riescono a rientrare né nel libero mercato né nei meccanismi dell’edilizia pubblica: quali sono le ragioni di questa esclusione?
Cecilia Guiglia. Esattamente. In alcuni casi, queste famiglie avrebbero anche le caratteristiche per accedere all’edilizia pubblica, ma il problema è che il patrimonio disponibile non è numericamente sufficiente a rispondere ai bisogni reali. Gli alloggi ERP vengono assegnati a persone che, oltre a un basso ISEE, presentano ulteriori fragilità: disabilità, anzianità, situazioni di emergenza. Oggi, se non si hanno queste caratteristiche aggiuntive, si resta in fondo alle graduatorie. E anche se si entra in graduatoria, a differenza degli anni ’60, oggi non si riesce più ad arrivare a ottenere un alloggio.
Ma queste famiglie non rientrano nemmeno nel mercato della locazione, figuriamoci in quello dell’acquisto. È per questo che abbiamo scelto di rivolgerci proprio a loro. Abbiamo definito un target molto preciso: famiglie monoreddito con figli minori, con un reddito mensile tra i 1.200 e i 1.600 euro. Parliamo di persone che non sono ancora formalmente definite “working poor”, ma che lo stanno diventando, specie con l’inflazione attuale. Anzi, se vogliamo dirla tutta, molti di noi che lavorano nel sociale vivono nella stessa condizione.
Ci siamo posti un duplice vincolo: da un lato, il livello di reddito di queste famiglie; dall’altro, l’incidenza dei costi abitativi sul reddito. Abbiamo stabilito che l’housing cost – cioè la somma di mutuo, fee alla Fondazione, quota mutualistica, spese condominiali, riscaldamento, acqua – dovesse rientrare nel 33% del reddito. Sono esclusi i costi delle utenze variabili. Questo ha guidato tutta la progettazione tecnico-economica.
E il dato che è emerso – ormai confermato anche in letteratura – è che per far quadrare operazioni immobiliari rivolte a questi target serve necessariamente una quota a fondo perduto pari ad almeno il 30% del costo complessivo. Il mercato non riesce a coprire questo scarto. Noi, all’inizio, avevamo ipotizzato di coprirlo grazie agli ecobonus, che purtroppo ci sono stati tolti a progettazione già avanzata. Ora siamo ancora alla ricerca di donatori o di investitori sociali per coprire quella quota.
Parallelamente, sono emerse altre scelte, più tecniche, legate alla progettazione architettonica e impiantistica. Abbiamo chiesto ai progettisti di ragionare fin da subito in funzione del reddito: gli alloggi sono piccoli, sostenibili dal punto di vista economico, pensati per nuclei con bambini. Gli spazi diurni – come i soggiorni – possono essere utilizzati anche per dormire, se necessario, mentre sono previsti spazi comuni condominiali pensati per i ragazzi. L’idea è quella di costruire flessibilità d’uso: se in casa ci sono tre bambini, uno può studiare nei locali comuni, mentre gli altri giocano in casa e il genitore può cucinare tranquillo. O viceversa.
Mario Flavio Benini. Quindi, qual è il taglio medio degli appartamenti?
Cecilia Guiglia. La media è di 50 metri quadrati. Su 16 alloggi sei sono più grandi – intorno ai 70 metri – mentre gli altri vanno dai 40 ai 54 metri quadri.
Mario Flavio Benini. E la ristrutturazione degli alloggi segue criteri di bioedilizia, efficientamento energetico, recupero delle acque piovane?
Cecilia Guiglia. L’intervento consiste nella ristrutturazione di un palazzo di inizio Novecento, di cui mira a conservare e valorizzare i caratteri e i materiali, recuperando e riutilizzando il più possibile l’esistente: in questo modo si limita l’impatto ambientale del cantiere Ovviamente le scelte per impianti e involucro garantiscono livelli elevati di efficientamento energetico, ed è previsto il recupero delle acque piovane. Però, ad esempio, abbiamo scelto di non realizzare il cappotto esterno. Al suo posto, abbiamo deciso di rifare i ballatoi interni, ampliandoli. Anche se non ci saranno più due alloggi sullo stesso ballatoio – perché cambierà la distribuzione – quei lunghi balconi restano una parte importante della struttura, in quanto garantiscono uno spazio all’aperto per ogni appartamento. Li abbiamo progettati in modo da essere parzialmente ombreggiati, perché il lato interno dell’edificio è molto assolato. Questo permetterà di proteggere gli ambienti dal caldo eccessivo, che oggi è uno dei problemi principali: ormai è più difficile difendersi dal caldo che dal freddo.
Abbiamo quindi fatto una scelta precisa: ottimizzare il riscaldamento naturale in inverno grazie all’esposizione, evitando però l’eccessivo surriscaldamento estivo. Per motivi sia economici che funzionali, abbiamo deciso di non coibentare i muri e non applicare il cappotto, puntando invece su altre strategie passive.
Mario Flavio Benini. Dal punto di vista energetico, avete previsto pannelli fotovoltaici o solare termico?
Cecilia Guiglia. Il solare termico è previsto, con un sistema di preriscaldamento dell’acqua posizionato sotto il tetto. Per quanto riguarda il fotovoltaico, stiamo partecipando a un bando: non è ancora garantito, ma è nei nostri piani.
Mario Flavio Benini. Fate parte anche di una comunità energetica rinnovabile solidale?
Cecilia Guiglia. Sì, facciamo già parte di una comunità energetica attiva sul territorio. È proprio quella comunità che sta partecipando al bando per dotare una serie di poli sociali – non solo residenziali – di impianti fotovoltaici. L’obiettivo è creare una rete energetica solidale, non solo tecnica ma anche sociale.
Mario Flavio Benini. In che modo viene favorita una partecipazione reale e non forzata dei futuri residenti e della comunità locale nelle scelte legate alla vita collettiva del CLT?
Cecilia Guiglia. Ci siamo detti fin dall’inizio che dovevamo fare attenzione a non creare obblighi, né imposizioni. Gli alloggi saranno completamente autonomi, e chi vorrà potrà scegliere di non partecipare alle attività comuni. Se una famiglia preferisce lavare i panni alla lavanderia a gettoni o nel proprio appartamento, e non nella lavanderia condominiale, è libera di farlo. È un’autonomia che abbiamo voluto preservare. Allo stesso tempo, però, c’è una consapevolezza condivisa: il fatto che i nuclei familiari saranno tutti con figli minori crea una base di omogeneità non per nazionalità o età, ma per condizioni di vita, e questo ci permette di immaginare forme di prossimità meno forzate.
Non si tratta di chiedere ai residenti di organizzare cene collettive obbligatorie una volta alla settimana. Ma l’idea che esistano spazi comuni accessibili anche ai bambini, e utilizzabili in modo libero e spontaneo, è un modo per facilitare la costruzione di relazioni. In questo senso, anche la composizione del gruppo dei futuri abitanti è importante: il percorso di costruzione collettiva è già iniziato, e proseguirà per almeno un anno. Durante questo tempo, ogni famiglia potrà valutare con attenzione la sostenibilità economica dell’operazione, ma anche maturare una consapevolezza condivisa rispetto alla natura del progetto.
Mario Flavio Benini. È previsto un accompagnamento all’abitare nel momento in cui gli alloggi verranno abitati?
Cecilia Guiglia. Sì, abbiamo previsto un percorso propedeutico all’ingresso negli alloggi, che non sarà solo informativo o tecnico, ma anche relazionale. Una delle componenti centrali sarà la realizzazione di uno spazio di prossimità: un luogo che non sarà riservato esclusivamente agli abitanti del CLT, ma aperto anche ai gruppi di cittadini già attivi sul territorio, che potranno riconoscerlo come un punto di riferimento, una sorta di casa comune.
In questo modo, l’accompagnamento non sarà pensato come un servizio “verso” qualcuno, ma come la creazione di un ecosistema di relazioni in cui le persone possano incontrarsi, conoscersi, riconoscersi. Non sarà solo la casa del quartiere a svolgere questa funzione, ma anche altri spazi di prossimità, distribuiti sul territorio. Questo permetterà di intercettare dinamiche e bisogni in modo più capillare.
Già oggi, nel nostro quartiere, esistono gruppi di abitanti che si prendono cura dei giardini pubblici, organizzano attività, sperimentano forme di auto-organizzazione. Uno degli obiettivi per i prossimi anni sarà mettere in rete questi gruppi, rafforzarli, costruire connessioni tra pratiche diverse ma complementari.
Mario Flavio Benini. Il riferimento a nuovi spazi civici mi fa pensare al progetto coordinato da Bertram Niessen per CheFare: c’è un dialogo con questo tipo di esperienze?
Cecilia Guiglia. Sì, anche a Torino si sta lavorando in quella direzione. L’amministrazione ha individuato nelle biblioteche uno dei luoghi potenzialmente più fertili per la prossimità. Sono spazi già presenti nei quartieri, spesso sottoutilizzati, che possono essere riattivati e abitati in modo nuovo. Si sta cercando di costruire lì dentro nuove opportunità, nuovi usi, nuove relazioni. Non è un’idea campata per aria: la logica è quella di riconoscere ai presìdi culturali – come le biblioteche – un ruolo anche sociale, comunitario, di animazione territoriale.
Allo stesso tempo, un altro filone di lavoro riguarda gli spazi pubblici aperti, come i grandi giardini urbani. In molti quartieri, il Comune ha individuato dei giardini problematici, luoghi dove si concentrano forme di fragilità, conflitto, solitudine. Noi proveremo a lavorare su uno di questi grandi giardini, costruendo intorno ad esso un presidio di prossimità. L’idea è quella di trasformare un luogo spesso percepito come insicuro o degradato in uno spazio abitato da relazioni positive, attività culturali, momenti di cura collettiva.
Mario Flavio Benini. Ma come evitare che la moltiplicazione degli spazi di prossimità crei dispersione invece che coesione?
Cecilia Guiglia. È una questione fondamentale. Se non si costruisce un’identità chiara e differenziata per ciascuno di questi luoghi, si rischia di generare confusione. Le persone oggi sono sommerse da informazioni, eventi, iniziative, e la vera sfida è proprio quella di rendere riconoscibili i luoghi della prossimità, di farli diventare familiari, affidabili, distinti tra loro.
Aumentare gli spazi e le opportunità non significa automaticamente aumentare la partecipazione. Perché questo avvenga, bisogna lavorare con attenzione sulla comunicazione, sull’accessibilità, sull’identità. E soprattutto bisogna continuare a radicare ogni intervento dentro le reti già esistenti, senza costruire strutture isolate, calate dall’alto. La prossimità non si dichiara: si costruisce giorno per giorno, nelle relazioni quotidiane.
Mario Flavio Benini. Oltre alle Case di Quartiere, quali altri modelli o presìdi di prossimità stanno emergendo a Torino? Le Portinerie di Comunità, ad esempio, si stanno rivelando una sperimentazione interessante?
Cecilia Guiglia. Sì, è così. In effetti sarebbe importante che anche le Portinerie di Comunità partecipassero a questo tipo di discussione. A Torino oggi non ci sono soltanto le Case di Quartiere: dopo il periodo del Covid è nato un sistema più articolato, chiamato “Torino Solidale”, dentro il quale sono emersi i cosiddetti S-Nodi. Alcuni di questi coincidono con le Case del Quartiere, ma altri si sono sviluppati in modo autonomo.
Nel nostro territorio, per esempio, l’unico altro s-nodo individuato – oltre alla Casa del Quartiere – è il Sermig, che però è uno snodo nazionale, non radicato sul territorio in senso stretto. Attorno alla nostra Casa del Quartiere si stanno consolidando una serie di altri spazi: la biblioteca, e nuove realtà in fase di apertura, come uno spazio dedicato ai bambini nei primi tre anni di vita, pensato per “agganciare” le mamme e creare opportunità educative e relazionali.
Tutto questo ci porta a riflettere su come costruire l’identità dei singoli spazi di comunità. La nostra Casa del Quartiere, per esempio, si sta caratterizzando sempre più per un lavoro con i giovani, ma anche sul benessere e la salute, e su alcune forme di fragilità. Altrove, invece, si stanno sviluppando esperienze più legate a specifici target. La biblioteca del quartiere, ad esempio, ha attivato un gruppo di donne vedove che si incontrano regolarmente. È importante evitare che ogni spazio diventi mono-tematico, o identificato solo con un gruppo. L’obiettivo è mescolare le esperienze, ma anche dedicare risorse specifiche per coltivare le diverse vocazioni.
Mario Flavio Benini. A che punto è oggi il progetto del Community Land Trust? Quali sono le prossime tappe fino alla consegna degli alloggi?
Cecilia Guiglia. Il progetto prevede di arrivare alla consegna degli appartamenti entro maggio 2027. Quindi abbiamo davanti ancora circa un anno e mezzo di lavoro. Il percorso è complesso, ma le tappe sono definite. Stiamo completando le ultime fasi tecniche e organizzative prima dell’avvio del cantiere vero e proprio.
Mario Flavio Benini. All’inizio del nostro colloquio accennava alla possibilità di replicare il modello del CLT in altri territori: quali sono le realtà con cui siete già in contatto e che stanno seguendo il vostro percorso?
Cecilia Guiglia. È un’idea che stiamo cercando di coltivare con convinzione. Abbiamo immaginato di creare una Consulta Nazionale sul CLT, aperta a tutte le realtà interessate a replicare questo modello. Il sogno era che ognuno potesse seguire il nostro percorso passo dopo passo, raccogliendo strumenti, competenze e pratiche da adattare localmente. Ma per il momento, questa consulta non è ancora partita.
Abbiamo però un Consiglio di Indirizzo molto ricco, con persone di grande competenza, e manteniamo relazioni attive con realtà pubbliche che si stanno avvicinando al tema. Le esperienze più promettenti sono tre: il Comune di Napoli, il Comune di Settimo Torinese e un piccolo comune della Basilicata.
A Napoli c’è molto fermento, e i ragionamenti in corso sono interessanti. A Settimo Torinese – una città di medie dimensioni – c’è un’attenzione concreta al tema dell’abitare, mentre nel comune lucano c’è un patrimonio immobiliare importante, ereditato da emigrati e messo a disposizione del Comune. Lì si sta studiando come trasformarlo in un’occasione per attrarre nuove famiglie.
In tutti e tre i casi si tratta di soggetti pubblici. Questo è significativo: la spinta a replicare il CLT, per ora, viene più da amministrazioni pubbliche e non dal privato o dal Terzo Settore. A Verona, ad esempio, la Fondazione di Comunità ci ha contattati e ha fatto una visita studio, ma anche lì è il pubblico a giocare un ruolo trainante. A Torino, invece, il pubblico è ancora nelle retrovie. Siamo noi, come attivisti e terzo settore, ad aver fatto il primo passo.
Mario Flavio Benini. Nella scelta di puntare sul modello del Community Land Trust avete lasciato sullo sfondo altre esperienze che in questi anni sono cresciute anche in Italia. Penso, ad esempio, a progetti come Dar=Casa a Milano, ai co-housing solidali in Toscana, agli ecovillaggi o ad AMA in Trentino: tutte esperienze che affrontano il tema dell’abitare da angolazioni diverse. Quali percorsi o modelli avete incontrato lungo il cammino e quali riflessioni vi hanno condotto, infine, a percorrere con decisione la strada del CLT?
Cecilia Guiglia. Io credo che oggi, più che scegliere un modello unico, abbia senso tenere aperte tre grandi domande che si intrecciano ma non si sovrappongono mai del tutto: come garantire l’accesso alla casa in modo sostenibile, quali sono le possibili forme dell’abitare e quali le forme di proprietà capaci di sfuggire alla logica del mercato speculativo. Sono tre assi di lavoro che spesso si incrociano due a due, ma difficilmente tutte e tre insieme. Noi, con il CLT, abbiamo scelto di partire con decisione dal nodo della proprietà, perché lo vedevamo come il più urgente da scardinare: volevamo capire se fosse possibile spezzare la dinamica del mercato immobiliare, senza rinunciare alla qualità dell’abitare.
Ovviamente ci portiamo dietro molte altre esperienze: chi di noi vive in cohousing, chi lavora da anni sulle forme dell’abitare condiviso, chi conosce bene i progetti di Abitare Solidale Toscana, o l’esperienza dell’associazione AMA in Trentino. Sono tutte realtà molto interessanti, come lo sono – da altri punti di vista – gli ecovillaggi. Ma molte di queste esperienze lavorano più sul piano culturale e relazionale dell’abitare, e meno sul nodo strutturale dell’accesso.
Poi c’è un’altra dimensione ancora: la questione dell’abitare dal punto di vista di chi vive situazioni di marginalità estrema, come le persone senza dimora. In questo senso, è vero, anche noi siamo stati molto colpiti e attratti dal modello Housing First. Lo abbiamo studiato e seguito con interesse, soprattutto per la sua capacità di mettere al centro l’abitare come diritto incondizionato. È un modello che lavora su un target molto eterogeneo, su persone che non hanno più accesso alla casa per motivi molto diversi: storie di vita, fallimenti, rotture, condizioni economiche o di salute. E spesso non si tratta solo di chi la casa l’ha persa, ma anche di chi ha scelto, in un certo senso, di lasciarla, perché era diventata un carico troppo pesante da sostenere.
Ma devo dire che il tema degli sfratti, è una questione a parte: lì la normativa, pur con tutti i suoi limiti, consente ancora qualche margine di intervento. Ma per le persone che restano fuori da tutto – senza residenza, senza tutele, senza prospettive – oggi manca completamente una risposta sistemica. È lì che il tema del diritto alla casa si mostra per quello che è: un diritto non garantito, né nella Costituzione né nelle politiche pubbliche. E quindi, anche nella nostra scelta di costruire un CLT, c’era il desiderio di misurarci con questa domanda radicale: è possibile costruire un modello che tenga insieme accessibilità, abitabilità e un uso non speculativo della proprietà?
Mario Flavio Benini. A Torino, accanto al lavoro sul Community Land Trust, esistono anche altre esperienze di supporto all’abitare rivolte a persone in condizione di vulnerabilità. Penso, ad esempio, alla collaborazione con Progetto Tenda, che lavora sia sull’Housing First sia su interventi più immediati, capaci di intercettare chi rischia di finire in strada. Qual è il vostro punto di vista su questi modelli e, più in generale, quali esperienze abitative innovative vi hanno colpito, anche a livello internazionale?
Cecilia Guiglia. Torino, da questo punto di vista, è una città che offre alcune risposte importanti. Penso, ad esempio, al servizio comunale dedicato a stranieri e minoranze etniche: chi arriva senza casa ha la possibilità di attivare immediatamente una richiesta di aiuto, spesso passando per un periodo in dormitorio, ma con un numero di posti di accoglienza ancora piuttosto elevato. È un sistema che, pur con tutti i suoi limiti, riesce almeno a garantire una prima soglia di accesso per alcune categorie fragili.
Il tema più complesso, per me, riguarda invece le forme dell’abitare oggi possibili e sensate per chi, semplicemente, non ha accesso alla casa. In questa direzione, durante i nostri momenti di studio e confronto, ci ha molto colpito un progetto realizzato a Vienna: la Residenza Sakura, progettata dallo studio di architettura Nerma Linsberger. Dal punto di vista tipologico, ricorda molto un’esperienza torinese a cui siamo legati, il Buena Vista Social Housing, oggi gestito dalla cooperativa Nanà. È un progetto nato all’interno del mondo della cooperazione di tipo B, come risposta a una consapevolezza molto chiara: aver generato numerosi posti di lavoro dignitosi ma fragili dal punto di vista economico. A partire da lì, si è cercato di costruire un’idea di welfare abitativo per i lavoratori stessi, unendo lavoro e abitare.
Il modello viennese, però, ha un respiro più ampio. Gli appartamenti sono in realtà mini-alloggi: stanze con bagno privato ma senza cucina, organizzate attorno a grandi spazi comuni piacevoli e funzionali – cucine condivise, sale per mangiare, caffetteria, luoghi di incontro. Ogni nucleo di coabitazione comprende cinque stanze, e il tutto è inserito in un edificio moderno e ben curato, nel pieno centro della città. Questo per me è un dato fondamentale: si tratta di abitazioni stabili, non pensate come soluzione transitoria. E questo cambia completamente la prospettiva.
Esperienze come questa mostrano che è possibile conciliare autonomia e condivisione, superando la solitudine ma senza cadere nell’obbligo della relazione. Ci raccontava una ragazza che oggi nel Buena Vista di Torino quegli spazi sono abitati anche da lavoratori stranieri con impieghi faticosi e orari lunghi, spesso impegnati in percorsi di ricongiungimento familiare. Per loro, vivere in un contesto semi-collettivo è un vantaggio: pagano circa 370 euro al mese tutto compreso, vivono in centro, hanno privacy, ma non sono isolati.
Da un punto di vista economico, queste soluzioni sono quasi più competitive di un monolocale tradizionale. A Torino, per esempio, trovare un appartamento sotto i 500 euro è sempre più difficile. Ma al di là della convenienza, ciò che conta è che si tratta di forme di vita: modalità di abitare che tengono insieme economia, relazione e qualità dello spazio.
Ci sono anche altre esperienze, come quelle delle coabitazioni leggere promosse a Trento o in Toscana, che cercano proprio di evitare un eccessivo carico relazionale. Perché molte forme innovative di abitare rischiano, se non ben gestite, di diventare luoghi affettivamente esigenti, che richiedono un investimento continuo nella convivenza. Invece ci sono persone – e non poche – che desiderano semplicemente vivere in pace, senza essere trascinate in dinamiche comunitarie obbligatorie. Trovare un equilibrio tra autonomia e prossimità è una delle sfide più delicate.
Da parte mia, non ho mai lavorato direttamente con persone in condizione di marginalità estrema, se non durante il periodo in cui ci siamo occupati della ricollocazione degli abitanti dell’ex MOI. Ma si trattava di un tipo di marginalità diversa, per quanto complessa. Oggi vediamo emergere nuove forme di esclusione che non assomigliano a quelle del passato, e per le quali dobbiamo forse inventare anche nuove forme dell’abitare, capaci di mescolare target, esperienze e traiettorie, senza costringere nessuno in modelli rigidi o stigmatizzanti.
Fondazione di Comunità Porta Palazzo
Sito Internet: hhttps://www.fondazioneportapalazzo.org
Facebook: https://www.facebook.com/fondazioneportapalazzo
Instagram: https://www.instagram.com/fondazioneportapalazzo/
YouTube: https://www.youtube.com/@FondazionePortaPalazzo

Lascia un commento