
commoning
Slow attitude, ovvero l’arte della decelerazione.
“Non esiste alcun modello unitario e universale di accelerazione che possa far accelerare ogni cosa. Al contrario molte cose rallentano, come il traffico in un ingorgo, mentre altre resistono caparbiamente a ogni tentativo di farle andare più in fretta”.
Hartmut Rosa
L’introduzione in Francia del diritto a “disconnettersi”, un contratto siglato dal alcune associazioni sindacali che rappresentano oltre 250.000 white-collar worker, istituisce una forte limitazione a quello che viene chiamato, “digital working time”, il lavoro svolto una volta lasciato l’ufficio tramite smartphone, computer o sistemi digitali. Il libro della co-fondatrice e direttore dell’Huffington Post Media Group, Arianna Huffington, “Cambiare passo. Oltre il denaro e il potere: la terza metrica per ridefinire successo e felicità” (Rizzoli 2014) che c’invita a smettere di inseguire un tipo di successo che in realtà ci uccide e coltivare la consapevolezza di ciò che davvero ci rende felici. Il saggio di Hartmut Rosa, “Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella tarda modernità” appena pubblicato in Italia da Einaudi 2015 (ne abbiamo parlato nel post “Andare a piedi. La filosofia del camminare di Frédéric Gros”) in cui il sociologo e filosofo tedesco paragona la velocità a una nuova forma di totalitarismo. Queste sono solo alcune tra le molte testimonianze che ci incoraggiano a decelerare, a diminuire una velocità che in nome della produttività e del progresso è ormai diventata una minaccia per l’ambiente, per il paesaggio, per il lavoro e per la nostra salute. Ma in quale modo siamo responsabili di questa pericolosa accelerazione delle nostre vite? Nel 2011, un sondaggio Ipsos condotto in Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania ha mostrato che il 77% degli intervistati desidera rallentare il proprio ritmo di vita.
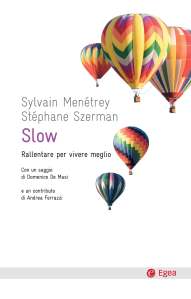 La questione del nostro rapporto con il tempo è al centro del movimento Slow, come scrive Stéphane Szerman, filosofo, e psicoterapeuta, autore con Sylvain Menétrey di “Slow: rallentare per vivere meglio” (Egea 2014): “Molte personalità in tutto il mondo ritengono che abbiamo ormai superato la soglia in cui l’accelerazione, a lungo considerata sinonimo di progresso e di benessere, diviene tossica, proprio come i titoli che hanno fatto vacillare il sistema bancario nel 2008. Ognuno nel proprio campo d’azione ha dato vita ad associazioni, correnti di pensiero e filosofie classificabili nella costellazione Slow. […] Per ognuno di essi, abbiamo svolto un’indagine storica e ci siamo interessati delle basi teoriche e ideologiche così come alle poste sociali in gioco che essi difendono. L’idea del libro è dunque esporre la visione del mondo secondo questi movimenti. […] Vivere e pensare Slow significa adeguare il proprio stile di vita ai ritmi naturali, essere sensibili alle stagioni, riacquisire la consapevolezza delle distanze, sviluppare una conoscenza dei prodotti e dell’ambiente. […] I movimenti Slow immaginano per le nostre società una soluzione benevola che passi attraverso la difesa della diversità, dell’incontro, dello scambio e della salvaguardia del patrimonio e uno sviluppo ponderato”.
La questione del nostro rapporto con il tempo è al centro del movimento Slow, come scrive Stéphane Szerman, filosofo, e psicoterapeuta, autore con Sylvain Menétrey di “Slow: rallentare per vivere meglio” (Egea 2014): “Molte personalità in tutto il mondo ritengono che abbiamo ormai superato la soglia in cui l’accelerazione, a lungo considerata sinonimo di progresso e di benessere, diviene tossica, proprio come i titoli che hanno fatto vacillare il sistema bancario nel 2008. Ognuno nel proprio campo d’azione ha dato vita ad associazioni, correnti di pensiero e filosofie classificabili nella costellazione Slow. […] Per ognuno di essi, abbiamo svolto un’indagine storica e ci siamo interessati delle basi teoriche e ideologiche così come alle poste sociali in gioco che essi difendono. L’idea del libro è dunque esporre la visione del mondo secondo questi movimenti. […] Vivere e pensare Slow significa adeguare il proprio stile di vita ai ritmi naturali, essere sensibili alle stagioni, riacquisire la consapevolezza delle distanze, sviluppare una conoscenza dei prodotti e dell’ambiente. […] I movimenti Slow immaginano per le nostre società una soluzione benevola che passi attraverso la difesa della diversità, dell’incontro, dello scambio e della salvaguardia del patrimonio e uno sviluppo ponderato”.
La velocità considerata come sinonimo di progresso, ha finito per avvelenare le nostra vite. Le innovazioni tecnologiche, progettate per semplificarci la vita, in realtà ci portano a fare sempre di più nella stessa unità di tempo. Tuttavia, al di la del nome, i seguaci dello Slow, opponendosi a questo circolo vizioso, alla cultura del ‘fatto male e in fretta’ e del ‘tutto e subito’ non militano per la lentezza in sé, ma per una forma di esistenza che smetta di preoccuparsi unicamente della logica a breve termine che governa la nostra società.
Slow Food, è la fonte di questo pensiero. Il termine ‘Slow Food’ è stato coniato nel corso di una manifestazione svoltasi nel 1986 in Piazza di Spagna a Roma contro l’apertura di un McDonald (“slow food” contro “fast food”). Tre anni dopo a Parigi, viene creata l’associazione Slow Food International, presieduta dal sociologo e critico gastronomico piemontese Carlo Petrini, e nel corso di un evento all’Opéra Comiche, i rappresentanti provenienti da quindici paesi firmano il “Manifesto Slow Food” redatto dal poeta Folco Portinari che definisce i principi del movimento: conservazione del patrimonio gastronomico individuando i prodotti alimentari e le modalità di produzione legati a un territorio, nell’ottica della salvaguardia della biodiversità; educazione al piacere e promozione della pratica di una diversa qualità della vita fatta del rispetto dei tempi naturali, dell’ambiente e della salute dei consumatori; incoraggiamento al consumo responsabile di prodotti locali e di stagione; valorizzazione della cultura gastronomica attraverso l’educazione dei cittadini alla conoscenza di produttori e territori; sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso le tematiche ambientali ed in particolare verso la salvaguardia della biodiversità e delle tradizioni culinarie…
In altre termini, per usare il titolo di un libro di Carlo Petrini si tratta di mangiare in modo “buono, pulito e giusto“ (“Buono, pulito e giusto. Princìpi di una nuova gastronomia“, Einaudi 2011). Scrive Szerman: “Buono, pulito e giusto: sono i tre criteri alla base della filosofia Slow Food. Li riassumiamo citando le parole di Jean Lhéritier, ex presidente di Slow Food France. Buono: è l’aspirazione di qualsiasi gourmet, la ricerca del piacere dei sensi. Pulito: è l’attuale preoccupazione dei cittadini decisi a proteggere il pianeta dalle minacce che incombono sui suoi ecosistemi. Giusto: è il diritto riconosciuto ai produttori di esistere ed esercitare la propria attività dignitosamente”.
Slow Food ha l’ambizione di rendere ‘universali’ questi tre princìpi, rendendo diritto all’alimentazione uno dei principali obiettivi dell’associazione. Nel 2010, al Salone del Gusto e Terra Madre (entrambi eventi di Slow Food), l’associazione ha annunciato il progetto “1000 orti in Africa” rilanciato nel 2014 da Slow Food con una campagna per realizzarne 10.000. L’intenzione è quella di aumentare di dieci volte il numero di orti presenti nel paese per riuscire a soddisfare le esigenze delle popolazioni locali e per contrastare il monopolio della grande distribuzione agroalimentare.
Sulla scia eco-gastronomica, l’attitudine Slow si è diffusa in molte aree: Slow Design, Slow Architecture, Cittàslow, Slow Money, Slow Science, Slow Education, Slow Book o Slow Reading, Slow Tourism, Slow Media, Slow Fashion… La filosofia Slow sta gradualmente diffondendosi in tutti gli aspetti della nostra vita, fino a infiltrarsi nelle camere da letto, nel cuore della nostra privacy. Per i discepoli dello Slow Sex, teorizzato nel 2002 da Alberto Vitale – che come Carlo Petrini è originario di Bra -, la compulsione, il sesso teso al risultato, l’egocentrismo incompatibile con l’amore, hanno ridotto il sesso a un puro atto di consumo; le donne e gli uomini a articoli del supermercato, eternamente insoddisfatti delle proprie relazioni. Per Vitale, intervistato da Carl Honoré nel suo “Elogio della lentezza: rallentare per vivere meglio” (BUR 2014), questa finzione corrisponde alla nostra realtà: “Nelle conversazioni maschili non si parla d’altro che del numero di donne, del numero di volte, del numero di posizioni. Sempre di numeri […] Si va a letto con un elenco di tappe da raggiungere. Si è troppo impazienti, troppo concentrati su sé stessi per apprezzare veramente il sesso”. Secondo Vitale, la ‘decelerazione erotica’, che consiste nel godersi il tempo e nell’offrirne, sarebbe il mezzo migliore per accedere al vero piacere dei sensi.
Proclamando il ‘diritto al godimento’, la generazione del ’68 libera i rigidi costumi degli occidentali, celebrando l’inizio un periodo di scoperta del corpo dell’altro e di nuove esperienze, periodo che si chiude negli anni ’80 con la comparsa dell’AIDS e la paura del contagio. Gli anni più recenti sono segnati da un fenomeno nuovo: l’influenza della tecnologia sulle nostre relazioni. La pornografia, non certo facilmente accessibile nei decenni precedenti, è ormai a portata di clic ed esibisce una sessualità spesso contrassegnata dal predominio maschile, fredda, violenta, frazionata in una serie di gesti da imparare e mettere in pratica, che un po’ alla volta sta eliminando modelli e immaginari alternativi. Lo Slow Sex, quindi, propone un pensiero controcorrente, basato sulla “decelerazione erotica”. Vale a dire, privilegiare, la lentezza, l’ascolto dei sentimenti e delle sensazioni, l’esplorazione del corpo dell’altro…
Negli Stati Uniti, il centro “One Taste Urban” è indiscutibilmente l’istituto più all’avanguardia nell’applicazione dello Slow Sex. Fondato nel 2001 a San Francisco da Nicole Daedone, la comunità organizza regolarmente seminari dedicati a varie pratiche come la meditazione o lo yoga. In un articolo pubblicato nella rivista Ravages , Nicole Daedone spiega: “Come lo Slow Food, lo Slow Sex è una filosofia di esplorazione del sesso fino alla sua forma più essenziale, per imparare a sentirlo profondamente nei nostri corpi e comunicare i nostri desideri. Ma così come non è possibile capire davvero lo Slow Food finché non si gusta il primo boccone, lo Slow Sex può essere compreso solo se provato”. Il sesso sarebbe dunque un ‘prodotto nostrano’ cucinato con amore che si assapora fisicamente e psicologicamente.
La consapevolezza delle devastazioni sociali e ambientali prodotte dal turismo di massa sta cambiando il nostro modo di viaggiare. Lo Slow Tourism, partigiano del ‘less is more’, va di pari passo con un interesse per il turismo responsabile e affonda le sue radici in nuova etica del viaggio che intende limitare l’impatto sull’ambiente. Il ‘turismo responsabile’ si suddivide in diverse famiglie, come il turismo sostenibile che raggruppa l’ecoturismo e il turismo rurale, il turismo equo, basato sui medesimi valori del commercio equo, il turismo solidale, associato ad azioni di sviluppo e di solidarietà, e il turismo etico, che privilegia lo sviluppo economico e la salvaguardia delle risorse naturali, culturali e sociali.
Scrive Szerman:
“Lo Slow Tourism si distingue da tali sottocategorie per l’interesse alle nozioni di piacere e di lentezza, proponendo un’alternativa al turismo di massa con la difesa di una locomozione lenta e poco inquinante, in barca, bicicletta o anche a cavallo. Invita a partire meno spesso ma a soggiornare più a lungo in una località, a seguire itinerari al di fuori dei percorsi turistici classici e a entrare in contatto con la popolazione per assorbire le sue conoscenze sulla regione visitata. Disapprova le corse ai musei, i programmi troppo densi e le visite lampo. Partire in trekking sulle montagne del Nepal, meditare in una grotta, fare il tour dell’Irlanda su una carrozza trainata da cavalli sono attività turistiche prossime all’accezione Slow. Ma a questi viaggi spesso organizzati lo Slow Tourism preferisce fondamentalmente le avventure solitarie e l’arte di arrangiarsi, le escursioni o i viaggi in cargo. L’influenza dei professionisti del turismo, il cui obiettivo è la vendita di viaggi, tende tuttavia a distorcere questa visione romantica per farne un argomento di marketing”.
Prendersi una pausa, disconnettersi, lasciarsi inebriare dalle bellezze della natura e dalla ricchezza del contatto umano è tanto più essenziale se la nostra vita professionale è stressante. Le conseguenze drammatiche da malattie dovute allo stress sul lavoro – burnout, depressione, suicidio, malattie cardiovascolari – secondo gli studi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (un’Agenzia delle Nazioni Unite), sono un fenomeno che ha un costo impressionante, compreso tra il 3 e il 4 per cento del PIL. Il concetto di Slow Management è recentissimo. Sono i professori dell’École de Management di Grenoble, Loïck Roche, John Sadowsky e Dominique Steiler, che lo hanno diffuso con un interessante libro, “Slow Management, éloge du bien être au travail”, pubblicato nel 2010 da PUG Grenoble. In quest’opera, gli autori difendono un management di prossimità, con il quale i dirigenti d’azienda e i quadri dedicano tempo alle risorse umane, ribadiscono costantemente i valori dell’impresa e comunicano un messaggio di verità ai propri collaboratori con l’obiettivo di “riportare umanità nell’impresa” e di ridare un senso all’attività di ognuno.
Scrive Stéphane Szerman:
“Lo Slow Management si inserisce in un’ottica riformista, sensibile alle esigenze e alle preoccupazioni dei lavoratori, senza mai adottare un approccio rivoluzionario. Il movimento ha l’obiettivo di sradicare lo stress, ormai percepito come un fattore nefasto in ragione delle numerose interruzioni dell’attività lavorativa e dei costi sanitari che genera, mentre fino a pochi anni fa lo si considerava ancora come un valore positivo”.
Il pericolo che si cela dietro questo tipo di filosofia è che insistendo sulla nozione di manager ‘guida’ si può finire col trasformare l’azienda in una sorta di setta fondata sul racconto ripetuto e su rituali che hanno la funzione di creare un sentimento di appartenenza e adesione ai valori dell’azienda. Insistendo sulla dimensione evangelizzatrice del manager si raggiunge in realtà lo stadio ultimo della feticizzazione del lavoro. Allo Slow Management, scrive l’autore di “Slow”: “Sarà dunque preferibile la visione più liberatrice del sociologo Vincent de Gaulejac e del giornalista Antoine Mercier. Partendo dai medesimi dati relativi al malessere e ai suicidi sul lavoro, essi arrivano alla conclusione che il problema dipende dall’influenza dell’’ideologia manageriale’ che funziona come il ‘partito comunista’ trasformandosi in dogma e infiltrandosi ovunque. Anziché una riforma del management, i due autori propongono di rovesciare con l’azione collettiva questa cultura che spezza la solidarietà. Essi assicurano che a lungo termine avremo bisogno di un “riequilibrio dei rapporti tra lavoro e capitale”. La teoria espressa in “La recherche malade du management” (QUAE 2012) non ha nulla a che vedere con lo Slow Management, ma forse può essere una prefigurazione della Slow Entreprise, una sorta di cooperativa del XXI secolo.
Nel 2009 il canale NRK della TV pubblica Norvegese ha deciso di trasmettere “Bergensbanen – minutt for minutt”, un treno che corre per sette ore lungo i binari. Un video visto da oltre un milione di norvegesi.
Bergensbanen minutt for minutt nrk 02 from Bent Dueholm Nørgaard on YouTube.
Il successo della prima trasmissione ha spinto NRK a produrre nel 2011 “Hurtigruten – minutt for minutt”, la diretta lunga 134 ore del viaggio di una nave da crociera che percorre 2600 chilometri lungo la costa norvegese (due milioni e mezzo di spettatori, circa la metà della popolazione norvegese, si sono sintonizzati sulla diretta). Lo scorso anno il canale France 4 ha mandato in onda “Tokyo Reverse”, un programma di nove ore in cui viene mostrato un uomo che passeggia per le strade di Tokio. Il filmato è stato girato in modo che mentre il protagonista continua a camminare verso la cinepresa, tutta la città sembra muoversi al contrario come se la pellicola si stesse riavvolgendo, quasi come se l”avanzare’ fosse elemento di disturbo in una società che gira alla rovescia, che arretra invece di progredire.
Tokyo Reverse – Extracts from Simon Bouisson on Vimeo.
Anche la BBC nel 2015 ha lanciato il progetto “BBC Four Goes Slow” che comprende tre programmi che celebrano all’idea di televisione lenta: “Make”, tre film da trenta minuti (Glass, Metal, Wood) che celebrano la tradizione artigianale; “The Canal”, due ore di viaggio, filmati in diretta, di un battello fluviale lungo uno dei corsi d’acqua storici della Gran Bretagna e lo straordinario “National Gallery”, tre ore di tour dietro le quinte della galleria accompagnati dal regista americano Frederick Wiseman.
La forza della Slow Tv, come di tutto ciò che appartiene alla filosofia degli Slow Media è proprio il suo essere l’opposto di ciò che viene oggi proposto dai media. Nel 2010 Benedikt Köhler, Sabria e David Jörg Blumtritt, tre giornalisti tedeschi hanno elaborato un manifesto degli Slow Media che descrive la filosofia del progetto: “Il concetto di “Slow” come in “Slow Food” è la chiave di questa trasformazione. Come con lo “Slow Food”, Slow Media non promuovono un consumo veloce, ma una ricerca attenta sugli ingredienti e una modalità di preparazione degli stessi. Gli Slow Media sono ospitali e di buona maniera. Ad essi piace condividere”.
Stéphane Szerman nel capitolo dedicato agli Slow Media scrive:
“Slow Media vede nelle nuove tecnologie la causa principale dell’accelerazione dei flussi mediatici. Internet e i cellulari hanno indubbiamente infranto le barriere temporali: i fatti sono riferiti in tempo reale, rendendo obsoleta la nozione di trattamento dei dati. I giornalisti devono lavorare a ritmi serrati. Il modello economico ancora poco redditizio di Internet ha indebolito gli editori, portando al ridimensionamento del personale di redazione. I professionisti dei mass media sono costretti dunque a lavorare più velocemente per soddisfare le esigenze dei nuovi mezzi di comunicazione, disponendo al contempo di meno strumenti e operando in condizioni peggiori. Internet ha inoltre banalizzato il modello della gratuità delle notizie, oggi utilizzato dai giornali, alcuni dei quali trasmettono un’informazione fast , talvolta cheap e quasi sempre senza sapore. Alcuni giornali gratuiti si presentano come gli equivalenti di McDonald’s nella stampa: formati standardizzati, spedizioni quasi industriali con una dose di cultura pop, un contenuto semplice ma poco soddisfacente per uno spirito esigente”.
Szerman documenta nel libro alcuni progetti realizzati negli ultimi anni come il progetto “Digital Detox Week” promosso dalla rivista americana “Adbuster”; le riviste XXI, “Usbek & Rica”, “Muze” e “Polka Magazine”; il progetto di Slow Journalism “The Sochi Project” di Rob Hornstra e Arnold van Bruggen realizzato nel 2009 per documentare i giochi olimpici di Sochi, o gli spazi informativi internet come “Global Magazine” e “Mediapart” che sperimentano un diverso approccio all’informazione.
The Sochi Project from Prospektor on Vimeo.
La tendenza alla decelerazione sembra essere parte di un più vasto movimento di riflessione su ciò che ci spinge a rinnovare e ad affermare nuovi valori. Siamo dunque all’alba di una trasformazione e di una ridefinizione della nostra società? È difficile affermarlo senza cadere in facili e fumose generalizzazioni. I movimenti Slow rappresentano una nicchia promettente e importante ma per ora hanno un impatto modesto sui nostri modelli di vita e di consumo.
“Slow: rallentare per vivere meglio” (Egea 2014) di Stéphane Szerman e Sylvain Menétreysu Amazon: http://amzn.to/1vOBK1w
Il sito internet di Stéphane Szerman è: http://www.szerman.fr/
Il canale YouTube: http://bit.ly/1QfAdAu
“Terra Madre” il film documentario di Ermanno Olmi: https://youtu.be/2xXCjK_zcAw
Slow Food
Slow Food International: www.slowfood.com
Slow Food Italia: www.slowfood.it
Terra Madre: www.terramadre.info
Salone del Gusto di Torino: www.salonedelgusto.it
Cittaslow
Cittaslow international: www.cittaslow.org.uk
Cittaslow nel mondo: www.cittaslow.org
Città di Transizione (nodo italiano): http://transitionitalia.wordpress.com
Slow Money
Slow Money: www.slowmoney.org
Investor’s Circle: www.investorscircle.net
Slow Education
Movimento Slow Education: www.slowmovement.com/slow_schools.php
Inchieste PISA: www.oecd.org/pisa
Slow Management
École de Management di Grenoble: www.grenoble-em.com
Slow Sex
Federico Fellini, La città delle donne, 1979 (scheda film): http://en.wikipedia.org/wiki/City_of_Women
Steve McQueen, Shame, 2011 (scheda film): http://en.wikipedia.org/wiki/Shame_(2011_film)
Slow Tourism
Slow Tourism: www.slowtourismclub.eu
Carta dei viaggiatori eco-responsabili: http://blog.voyages-eco-responsables.org /-association/les-chartes
Carta dei tour operator eco-responsabili: http://blog.voyages-eco-responsables.org /-association/les-chartes
Associazione Italiana Turismo Responsabile: www.aitr.org
Slow Design
Droog Design: hwww.droog.com
Alastair Fuad-Luke: www.fuad-luke.com
SlowLab: www.slowlab.net
Ezio Manzini: www.scenocosme.com/souffles.htm
5.5 designers: www.5-5designstudio.com
Sustainable Everyday Project: www.sustainable-everyday.net
Slow Architecture
Slow Architecture: www.slow-architecture.com
Wang Shu: www.chinese-architects.com
Eduardo Souto de Moura: www.pritzkerprize.com/laureates/2011
Enrico Frigerio: www.frigeriodesign.it
Slow Book
Slowbook Farm: http://slowbookfarm.wordpress.com
Slow Book Movement: join@slowbookmovement.com
Portale delle case editrici francesi indipendenti: www.lekti-ecritures.net
Altro sito Slow Book in Francia: www.librairiemonet.com
Slow Media
Slow Media: www.slowmedia.eu
Jennifer Rauch: http://jennifer- rauch.com
Carl Honoré: www.carlhonore.com
Digital Detox Week: www.adbusters.org/campaigns/digitaldetox
Manifesto Slow Media: http://en.slow- media.net/manifesto
Pagina francese degli adepti dello Slow Media su Facebook
Slow Media in Germania: http://www.slow- media.net
Slow Media in USA: www.slowmedia.typepad.com
Progetto Sochi: www.thesochiproject.org
Slow Science
Slow Science Academy e suo manifesto: http://slow- science.org
Slow Music
Amiina: www.amiina.com
STSassociation: www.youtube.com/stsassociation
Discussione